Morning sun breaks through the trees
Swaying gently on the morning breeze
Dappled shadows in the village square
Soft breeze blows away the chill night air
People gather in a dusty street
Stalls are opening, the old folk meet
Conversations on the morning air
Another day is dawning in Halabja village square
Children safe behind school yard gates
A few last stragglers arriving late
Teachers ready for another busy day
A time to study and a time to pray
Sweet, sweet breeze blows through the town
Gently flowing, makes no sound
Trickles silent beneath the doors
Like the sea laps against the shore
No bird song, no sound in the street
The school lies still, no clatter of feet
A sweet sweet fragrance hangs in the air
Deadly harvest in Halabja village square
A gift from France and the USA
Love and kisses from the UK
Soft skinned handshakes behind closed doors
Vultures gather to count the score
It’s got nothing to do with me
I cannot hear, I cannot see
It’s got nothing to do with me
It’s not on my TV
I’m the king of the castle and you’re the dirty rascal
A gift from France and the USA
Love and kisses from the UK
Soft skinned handshakes behind closed doors
Vultures gather to count the score
Swaying gently on the morning breeze
Dappled shadows in the village square
Soft breeze blows away the chill night air
People gather in a dusty street
Stalls are opening, the old folk meet
Conversations on the morning air
Another day is dawning in Halabja village square
Children safe behind school yard gates
A few last stragglers arriving late
Teachers ready for another busy day
A time to study and a time to pray
Sweet, sweet breeze blows through the town
Gently flowing, makes no sound
Trickles silent beneath the doors
Like the sea laps against the shore
No bird song, no sound in the street
The school lies still, no clatter of feet
A sweet sweet fragrance hangs in the air
Deadly harvest in Halabja village square
A gift from France and the USA
Love and kisses from the UK
Soft skinned handshakes behind closed doors
Vultures gather to count the score
It’s got nothing to do with me
I cannot hear, I cannot see
It’s got nothing to do with me
It’s not on my TV
I’m the king of the castle and you’re the dirty rascal
A gift from France and the USA
Love and kisses from the UK
Soft skinned handshakes behind closed doors
Vultures gather to count the score
envoyé par Donquijote82 - 1/2/2015 - 22:53
LIBERTA’ PROVVISORIA PER I QUATTRO CURDI ANCORA IN CARCERE DOPO LA MANIFESTAZIONE DEL 3 DICEMBRE
Gianni Sartori
Il 3 dicembre 2021 decine di militanti di TCS e di TEKO-JIN (movimenti della Gioventù Curda in Europa) manifestavano vigorosamente all’Aia (Paesi Bassi) davanti alla sede dell’OPCW, l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.
C’era anche stato un tentativo di occupazione (definito dai media un “assalto”), ma solo dopo la carica della polizia contro i giovani radunati all’esterno. Scopo dell’iniziativa, denunciare all’opinione pubblica quanto stava avvenendo nel Kurdistan posto entro i confini iracheni. Dove l’esercito turco andava impiegando gas tossici contro la resistenza curda. Alcuni manifestanti si erano anche incatenati e alla fine una cinquantina di loro venivano arrestati. Almeno dieci i feriti (sempre tra i manifestanti).
Per quaranta dei fermati l'accusa era di “rottura della pace sociale, distruzione e violenza contra le proprietà di un’organizzazione protetta a livello internazionale”.
Altri quattro (Sinan E., Abdullah G., Serhat E., Hakan H. e Hugo G.) erano finora rimasti in stato di detenzione per “violenza in associazione contro persone, violenza contro le proprietà di un’organizzazione internazionalmente protetta e vandalismo”. Quella del 3 dicembre non era la prima iniziativa dei giovani curdi per denunciare l’uso delle armi chimiche. Un mese prima - il 3 novembre 2021 - si era svolta una manifestazione simile (sempre davanti alla sede dell’OPCW) e poi un’altra il 16 novembre.
Ma il grido di dolore della comunità curda era rimasto inascoltato.
Organizzate soprattutto da Radical Solidarity, nel mese di gennaio sono state indette numerose iniziative di solidarietà per i quattro curdi rimasti in carcere. Un po’ ovunque nei Paesi Bassi e anche a Bruxelles (davanti all’ambasciata dei Paesi Bassi, a sorpresa).
Il 26 gennaio i quattro sono stati rimessi in libertà provvisoria in attesa del processo, previsto per il 17 febbraio.
Gianni Sartori
Gianni Sartori
Il 3 dicembre 2021 decine di militanti di TCS e di TEKO-JIN (movimenti della Gioventù Curda in Europa) manifestavano vigorosamente all’Aia (Paesi Bassi) davanti alla sede dell’OPCW, l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.
C’era anche stato un tentativo di occupazione (definito dai media un “assalto”), ma solo dopo la carica della polizia contro i giovani radunati all’esterno. Scopo dell’iniziativa, denunciare all’opinione pubblica quanto stava avvenendo nel Kurdistan posto entro i confini iracheni. Dove l’esercito turco andava impiegando gas tossici contro la resistenza curda. Alcuni manifestanti si erano anche incatenati e alla fine una cinquantina di loro venivano arrestati. Almeno dieci i feriti (sempre tra i manifestanti).
Per quaranta dei fermati l'accusa era di “rottura della pace sociale, distruzione e violenza contra le proprietà di un’organizzazione protetta a livello internazionale”.
Altri quattro (Sinan E., Abdullah G., Serhat E., Hakan H. e Hugo G.) erano finora rimasti in stato di detenzione per “violenza in associazione contro persone, violenza contro le proprietà di un’organizzazione internazionalmente protetta e vandalismo”. Quella del 3 dicembre non era la prima iniziativa dei giovani curdi per denunciare l’uso delle armi chimiche. Un mese prima - il 3 novembre 2021 - si era svolta una manifestazione simile (sempre davanti alla sede dell’OPCW) e poi un’altra il 16 novembre.
Ma il grido di dolore della comunità curda era rimasto inascoltato.
Organizzate soprattutto da Radical Solidarity, nel mese di gennaio sono state indette numerose iniziative di solidarietà per i quattro curdi rimasti in carcere. Un po’ ovunque nei Paesi Bassi e anche a Bruxelles (davanti all’ambasciata dei Paesi Bassi, a sorpresa).
Il 26 gennaio i quattro sono stati rimessi in libertà provvisoria in attesa del processo, previsto per il 17 febbraio.
Gianni Sartori
Gianni Sartori - 26/1/2022 - 23:22
LA RIVOLTA INSURREZIONALE CONTINUA IN ROJHILAT E IRAN
Gianni Sartori
Sono trascorse ormai quasi due settimane dall’inizio della rivolta per l’assassinio di Jina Mahsa Amin. Rivolta che dal Kurdistan “iraniano” (Rojhilat) si è estesa all’intero Paese, coinvolgendo ben 156 località. E il numero delle vittime - com’era prevedibile - è andato crescendo in maniera esponenziale. Alcune fonti locali ipotizzano la cifra di almeno 240 manifestanti caduti sotto i colpi della repressione. Gli arresti sarebbero oltre dodicimila (di cui buona parte nel Rojhilat).
Ma nonostante il massiccio dispiegamento di Pasdaran, milizie Bassidj e agenti non in divisa che si infiltrano nei cortei, le proteste proseguono autoalimentandosi.
Le manifestazioni e gli scontri avvengono soprattutto nelle ore notturne, sia a Teheran che Tabriz, Machad, Chiraz, Racht e Karadj.
Soltanto nella serata del 25 settembre gli insorti si sono scontrati con i Pasdaran in una decina di zone di Teheran (Narmak, Sadeghieh, Hafthoz, Ekbatan, Sattar Khan…) e sulla superstrada Shariati. Tra gli slogan scanditi: “Abbasso Khamenei, abbasso la dittatura”. Sempre a Teheran sono stati incendiati vari cartelloni di propagande del regime e alcune moto della polizia. Così nella zona di Narmak dove altre moto e un’auto della polizia sono state date alle fiamme. Altre manifestazioni si svolgevano contemporaneamente a Pounak, Pardis e Ekbatan. Così come nelle zone universitarie. A Karadj,per rallentare le proteste, la polizia ha tolto l’elettricità. Invano.
Inoltre dal 26 settembre numerosi insegnanti e studenti universitari sono entrati in sciopero della fame per protestare contro i massicci arresti di studenti.
Ma nel frattempo, adottando la stessa strategia di Ankara, il 28 settembre Teheran ha voluto colpire nuovamente i curdi (perno dell’attuale rivolta contro il regime) anche nel nord dell’Iraq, nel Kurdistan “iracheno” (Bashur).
Nell’ultimo attacco una quindicina di persone sono state uccise e una cinquantina ferite (soprattutto donne e bambini, comunque civili) in un attacco dei Pasdaran con uso di artiglieria, missili e droni contro un campo di rifugiati curdi a Koysinjaq (a est di Erbil).
Questi attacchi durano ormai da una settimana e ufficialmente avvengono per colpire le basi della resistenza curda iraniana che fornirebbe sostegno alla rivolta in atto. In realtà ad essere colpiti sono soprattutto obiettivi e persone civili. Come a Koya dove il bombardamento di una scuola ha provocato una ventina di feriti tra i bambini.
Due delle ultime vittime appartenevano al PDK-I (Partito democratico del Kurdistan d’Iran).
Altri attacchi sono avvenuti contro presunte basi di Komala, del Partito per libertà del Kurdistan (PAK) e del Partito per una Vita Libera in Kurdistan (PJAK).
Attaccati ormai simultaneamente sia da Ankara che da Teheran così nel Kurdistan “siriano” come nel Kurdistan “iracheno”, i Curdi tuttavia non si arrendono.
Da segnalare la polemica, in realtà una legittima rivendicazione, sorta in merito all’utilizzo generalizzato da parte dei manifestanti dello slogan curdo e femminista “Jin, Jiyan, Azadi” (Donna, Vita, Libertà).
Nel primo giorno della protesta si era cominciato a sentirlo scandire nella città natale di Jina Mahsa Amini, Saqqez. Da qui poi aveva preso piede nell’intero Paese.
Tuttavia, come segnalano (citando uno scritto di Hawzhin Azeez) alcuni militanti curdi “gli iraniani e le iraniane che lo gridano spesso non ne conoscono né l’origine, né l’autentico significato. Rappresenta una lotta avviato ormai da 40 anni (dalla fondazione del PKK nda), al prezzo della vita di migliaia di donne e uomini curdi in lotta contro il colonialismo turco, persiano e arabo nel Kurdistan”.
A loro consigliano, prima di scandire ancora “Jin, Jiyan, Azadi” di informarsi e di chiedersi se in quanto appartenenti comunque a uno dei gruppi dominanti possono legittimamente appropriarsene.
Gianni Sartori
Sono trascorse ormai quasi due settimane dall’inizio della rivolta per l’assassinio di Jina Mahsa Amin. Rivolta che dal Kurdistan “iraniano” (Rojhilat) si è estesa all’intero Paese, coinvolgendo ben 156 località. E il numero delle vittime - com’era prevedibile - è andato crescendo in maniera esponenziale. Alcune fonti locali ipotizzano la cifra di almeno 240 manifestanti caduti sotto i colpi della repressione. Gli arresti sarebbero oltre dodicimila (di cui buona parte nel Rojhilat).
Ma nonostante il massiccio dispiegamento di Pasdaran, milizie Bassidj e agenti non in divisa che si infiltrano nei cortei, le proteste proseguono autoalimentandosi.
Le manifestazioni e gli scontri avvengono soprattutto nelle ore notturne, sia a Teheran che Tabriz, Machad, Chiraz, Racht e Karadj.
Soltanto nella serata del 25 settembre gli insorti si sono scontrati con i Pasdaran in una decina di zone di Teheran (Narmak, Sadeghieh, Hafthoz, Ekbatan, Sattar Khan…) e sulla superstrada Shariati. Tra gli slogan scanditi: “Abbasso Khamenei, abbasso la dittatura”. Sempre a Teheran sono stati incendiati vari cartelloni di propagande del regime e alcune moto della polizia. Così nella zona di Narmak dove altre moto e un’auto della polizia sono state date alle fiamme. Altre manifestazioni si svolgevano contemporaneamente a Pounak, Pardis e Ekbatan. Così come nelle zone universitarie. A Karadj,per rallentare le proteste, la polizia ha tolto l’elettricità. Invano.
Inoltre dal 26 settembre numerosi insegnanti e studenti universitari sono entrati in sciopero della fame per protestare contro i massicci arresti di studenti.
Ma nel frattempo, adottando la stessa strategia di Ankara, il 28 settembre Teheran ha voluto colpire nuovamente i curdi (perno dell’attuale rivolta contro il regime) anche nel nord dell’Iraq, nel Kurdistan “iracheno” (Bashur).
Nell’ultimo attacco una quindicina di persone sono state uccise e una cinquantina ferite (soprattutto donne e bambini, comunque civili) in un attacco dei Pasdaran con uso di artiglieria, missili e droni contro un campo di rifugiati curdi a Koysinjaq (a est di Erbil).
Questi attacchi durano ormai da una settimana e ufficialmente avvengono per colpire le basi della resistenza curda iraniana che fornirebbe sostegno alla rivolta in atto. In realtà ad essere colpiti sono soprattutto obiettivi e persone civili. Come a Koya dove il bombardamento di una scuola ha provocato una ventina di feriti tra i bambini.
Due delle ultime vittime appartenevano al PDK-I (Partito democratico del Kurdistan d’Iran).
Altri attacchi sono avvenuti contro presunte basi di Komala, del Partito per libertà del Kurdistan (PAK) e del Partito per una Vita Libera in Kurdistan (PJAK).
Attaccati ormai simultaneamente sia da Ankara che da Teheran così nel Kurdistan “siriano” come nel Kurdistan “iracheno”, i Curdi tuttavia non si arrendono.
Da segnalare la polemica, in realtà una legittima rivendicazione, sorta in merito all’utilizzo generalizzato da parte dei manifestanti dello slogan curdo e femminista “Jin, Jiyan, Azadi” (Donna, Vita, Libertà).
Nel primo giorno della protesta si era cominciato a sentirlo scandire nella città natale di Jina Mahsa Amini, Saqqez. Da qui poi aveva preso piede nell’intero Paese.
Tuttavia, come segnalano (citando uno scritto di Hawzhin Azeez) alcuni militanti curdi “gli iraniani e le iraniane che lo gridano spesso non ne conoscono né l’origine, né l’autentico significato. Rappresenta una lotta avviato ormai da 40 anni (dalla fondazione del PKK nda), al prezzo della vita di migliaia di donne e uomini curdi in lotta contro il colonialismo turco, persiano e arabo nel Kurdistan”.
A loro consigliano, prima di scandire ancora “Jin, Jiyan, Azadi” di informarsi e di chiedersi se in quanto appartenenti comunque a uno dei gruppi dominanti possono legittimamente appropriarsene.
Gianni Sartori - 29/9/2022 - 12:26
IRAN: CHI STRUMENTALIZZA CHI?
Gianni Sartori
Ovviamente ogni rivolta, soprattutto quando configura passaggi rivoluzionari, oltre a quello - scontato - di venir sanguinosamente repressa, corre il rischio di essere strumentalizzata, incanalata, dirottata altrove.
Da qualche decennio su alcuni contenuti ineludibili delle attuali ribellioni (il femminismo, l’ecologia, l’antirazzismo, i diritti umani, la critica dell'antropocentrismo…) abbiamo visto volteggiare gli avvoltoi (metafora: chiedo scusa ai simpatici volatili) delle classi dominanti e delle loro “operazioni umanitarie” (a base di bombardamenti e invasioni) imperialiste.
Questo vale anche per ciò che sta accadendo in Iran, ma senza per questo togliere una briciola di legittimità all’insurrezione nata dalla protesta per la morte di Jina Mahsa Amini, una giovane curda di 22 anni (arrestata e torturata per un velo “portato male”) il 16 settembre.
Rivolta innescata nel Rojhilat per poi estendersi all’intero paese.
In ogni caso compito dei ribelli curdi e iraniani sarà quello di vigilare per non diventare la carne da cannone di chi vuole semplicemente sostituire un potere indegno con uno magari peggiore.
E’ il caso della destra iraniana (in genere nostalgica dello scià) che - secondo alcuni osservatori curdi - starebbe cercando di “impadronirsi del movimento popolare” e che godrebbe “del sostegno di forze di destra in Occidente”.
Per questo Somayeh Rostampour, una curda iraniana, sta mettendo in guardia contro “il tentativo dei realisti (assolutamente di destra) di recuperare la contestazione in Iran”.
Per l’attivista “così come avvenne con il Khomeinismo negli anni settanta, attualmente i realisti godono dell’appoggio a livello mondiale delle forze più di destra, talvolta fasciste e in genere antifemministe”.
Si starebbe assistendo al confronto tra due opposte visioni del mondo: “la destra maschilista e la sinistra femminista”.
La prima gode del sostegno di chi possiede mezzi finanziari e li mette a disposizione, mentre l’altra è appoggiata dalle forze progressiste, dalle donne e dagli oppressi e diseredati del pianeta.
Schema troppo semplice? Forse, ma non certo privo di fondamento.
Spiega ancora Somayeh Rostampour che “se vogliamo scrivere esattamente il contrario di “Jin, Jiyan, Azadî” (Donna, Vita, Libertà, uno degli slogan più gridati in questi giorni, non solo nel Rojhilat nda) dovremmo scrivere “Uomo, Patria, Popolo”.
Ossia un “elogio del nazionalismo, del governo patriarcale e del culto del suolo basato su un modello maschile”.
Invece l’attuale movimento si distingue da quelli precedenti proprio in quanto non è “soltanto una rivoluzione politica, ma anche una rivoluzione sociale”. Rivolta a “trasformare simultaneamente le strutture sociali, politiche e storiche”.
Secondo l’attivista curda la storia del Paese è talmente mescolata al maschilismo che “non è tollerabile (per il regime ovviamente nda) assistere allo spettacolo di uno spazio autonomo femminile come quello dell’attuale rivolta per ben due settimane di seguito”.
In effetti, nel più benevolo dei giudizi, le femministe sono state definite “stravaganti”.
Quanto ai progetti di restaurazione della monarchia, rientrati in gioco infiltrando (o almeno cercando di infiltrare, infettare…) il movimento, non si tratterebbe soltanto di diffondere un visione reazionaria (tanto quanto l’islamismo), ma di un vero e proprio “progetto politico sostenuto finanziariamente e politicamente dalle forze di estrema destra in maniera coordinata e sistematica”.
Applicando in maniera perversa il concetto situazionista di “detournement”, si sta cercando di snaturare questa ribellione radicale nel suo opposto. Ossia in un movimento sì di opposizione, ma dai contenuti regressivi: sessisti, maschilisti e razzisti.
Quindi dietro la retorica di certa destra monarchica iraniana (anche o soprattutto all’estero) a base di “Uniamoci” si va profilando un progetto di opposizione all’attuale regime, ma intriso di ostilità diffidenza, esclusione nei confronti delle donne, delle minoranze sessuali, dei gruppi etnici non persiani. E di aperta ostilità (premessa di future repressioni) verso la sinistra rivoluzionaria e i dissidenti in genere.
E questi propositi di strumentalizzare l’odierna rivolta, si potrebbero coniugare con quelli abituali dell’Occidente.
Rivestire, mascherare le pulsioni neocoloniali con l’esportazione - non richiesta - del modello occidentale.
Gianni Sartori
Gianni Sartori
Ovviamente ogni rivolta, soprattutto quando configura passaggi rivoluzionari, oltre a quello - scontato - di venir sanguinosamente repressa, corre il rischio di essere strumentalizzata, incanalata, dirottata altrove.
Da qualche decennio su alcuni contenuti ineludibili delle attuali ribellioni (il femminismo, l’ecologia, l’antirazzismo, i diritti umani, la critica dell'antropocentrismo…) abbiamo visto volteggiare gli avvoltoi (metafora: chiedo scusa ai simpatici volatili) delle classi dominanti e delle loro “operazioni umanitarie” (a base di bombardamenti e invasioni) imperialiste.
Questo vale anche per ciò che sta accadendo in Iran, ma senza per questo togliere una briciola di legittimità all’insurrezione nata dalla protesta per la morte di Jina Mahsa Amini, una giovane curda di 22 anni (arrestata e torturata per un velo “portato male”) il 16 settembre.
Rivolta innescata nel Rojhilat per poi estendersi all’intero paese.
In ogni caso compito dei ribelli curdi e iraniani sarà quello di vigilare per non diventare la carne da cannone di chi vuole semplicemente sostituire un potere indegno con uno magari peggiore.
E’ il caso della destra iraniana (in genere nostalgica dello scià) che - secondo alcuni osservatori curdi - starebbe cercando di “impadronirsi del movimento popolare” e che godrebbe “del sostegno di forze di destra in Occidente”.
Per questo Somayeh Rostampour, una curda iraniana, sta mettendo in guardia contro “il tentativo dei realisti (assolutamente di destra) di recuperare la contestazione in Iran”.
Per l’attivista “così come avvenne con il Khomeinismo negli anni settanta, attualmente i realisti godono dell’appoggio a livello mondiale delle forze più di destra, talvolta fasciste e in genere antifemministe”.
Si starebbe assistendo al confronto tra due opposte visioni del mondo: “la destra maschilista e la sinistra femminista”.
La prima gode del sostegno di chi possiede mezzi finanziari e li mette a disposizione, mentre l’altra è appoggiata dalle forze progressiste, dalle donne e dagli oppressi e diseredati del pianeta.
Schema troppo semplice? Forse, ma non certo privo di fondamento.
Spiega ancora Somayeh Rostampour che “se vogliamo scrivere esattamente il contrario di “Jin, Jiyan, Azadî” (Donna, Vita, Libertà, uno degli slogan più gridati in questi giorni, non solo nel Rojhilat nda) dovremmo scrivere “Uomo, Patria, Popolo”.
Ossia un “elogio del nazionalismo, del governo patriarcale e del culto del suolo basato su un modello maschile”.
Invece l’attuale movimento si distingue da quelli precedenti proprio in quanto non è “soltanto una rivoluzione politica, ma anche una rivoluzione sociale”. Rivolta a “trasformare simultaneamente le strutture sociali, politiche e storiche”.
Secondo l’attivista curda la storia del Paese è talmente mescolata al maschilismo che “non è tollerabile (per il regime ovviamente nda) assistere allo spettacolo di uno spazio autonomo femminile come quello dell’attuale rivolta per ben due settimane di seguito”.
In effetti, nel più benevolo dei giudizi, le femministe sono state definite “stravaganti”.
Quanto ai progetti di restaurazione della monarchia, rientrati in gioco infiltrando (o almeno cercando di infiltrare, infettare…) il movimento, non si tratterebbe soltanto di diffondere un visione reazionaria (tanto quanto l’islamismo), ma di un vero e proprio “progetto politico sostenuto finanziariamente e politicamente dalle forze di estrema destra in maniera coordinata e sistematica”.
Applicando in maniera perversa il concetto situazionista di “detournement”, si sta cercando di snaturare questa ribellione radicale nel suo opposto. Ossia in un movimento sì di opposizione, ma dai contenuti regressivi: sessisti, maschilisti e razzisti.
Quindi dietro la retorica di certa destra monarchica iraniana (anche o soprattutto all’estero) a base di “Uniamoci” si va profilando un progetto di opposizione all’attuale regime, ma intriso di ostilità diffidenza, esclusione nei confronti delle donne, delle minoranze sessuali, dei gruppi etnici non persiani. E di aperta ostilità (premessa di future repressioni) verso la sinistra rivoluzionaria e i dissidenti in genere.
E questi propositi di strumentalizzare l’odierna rivolta, si potrebbero coniugare con quelli abituali dell’Occidente.
Rivestire, mascherare le pulsioni neocoloniali con l’esportazione - non richiesta - del modello occidentale.
Gianni Sartori
Gianni Sartori - 29/9/2022 - 19:20
Ieri Halabja, oggi (dicembre 2022) Çemço: nel Kurdistan iracheno (e nell’indifferenza universale) ancora guerra chimica contro i curdi
Passato alla storia come il “massacro di Halabja”, l’attacco con armi chimiche proibite dalla Convenzione di Ginevra avvenne tra il 16 e il 19 marzo 1988. Halabja (città della provincia di as-Sulaymaniya) era caduta il giorno prima, 15 marzo 1988, in mano alla formazione curda dell’UPK (Unione Patriottica Curda) guidata da Jalal Talabani.
Eravamo in piena guerra Iran-Iraq (avviata nel 1980) e, come è noto (vedi l’abbattimento da parte dell’Incrociatore USS Vincennes dell’Airbus A300 iraniano - 290 vittime tra cui 66 bambini - solo qualche mese dopo, in luglio) l’Occidente (o meglio: gli Stati Uniti) era all’epoca sostanzialmente schierato con Bagdad.
Il massacro di Halabja fu il risultato dell’impiego di gas chimici (gas mostarda) per ordine di Ali Hassan al-Majid (conosciuto come “Ali il Chimico”, poi condannato a morte e giustiziato). Per l’operazione genocida (inserita nella più vasta operazione Anfal, dal febbraio al settembre 1988) l’aviazione irachena si servì di caccia-bombardieri MiG-31 e Mirage. I morti accertati (tutti curdi) furono oltre cinquemila.
Una prima serie di attacchi aerei contro Halbja era già avvenuta dal 23 febbraio al 19 marzo 1988, quando la città era caduta in mano all’esercito iraniano.
Complessivamente l’operazione Anfal, ideata esplicitamente contro la popolazione curda, provocò la morte di circa 180mila persona e la distruzione del 90% dei villaggi curdi del Bashur (il Kurdistan posto all’interno dei confini iracheni). Oltre alla deportazione di gran parte dei curdi sopravvissuti.
Quindi, niente di nuovo sotto il sole iracheno, per quanto opacizzato dalle nubi dei gas. Anche recentemente (nei giorni 7,8 e 9 dicembre 2022 per la cronaca) si torna a parlare di gas chimici impiegati contro la Resistenza curda. Stavolta per mano della Turchia.
Ankara prosegue imperterrita nella brutale operazione di occupazione militare e rastrellamento (ai limiti della pulizia etnica) lanciata il 15 aprile. Operazione che ha visto (soprattutto in settembre) un ampio utilizzo di sostanze tossiche proibite dalla Convenzione di Ginevra.
Anche se, va detto, sembra incontrare non poche difficoltà come starebbero a dimostrare i video diffusi dalla guerriglia curda che appare in grado non solo di resistere, ma anche di infliggere duri colpi alle truppe di occupazione. In questo momento i combattimenti più aspri si starebbero svolgendo nella regione di Medya. Qui l’esercito turco cercherebbe di stanare la resistenza curda dalla vasta rete di grotte, anfratti e tunnel in cui trova rifugio tra i combattimenti. In particolare la zona di Çemço (dove la residenza è più consolidata) sarebbero stati colpiti con armi chimiche decine di volte nei giorni già citati (7, 8 e 9 dicembre ).
Gianni Sartori
Passato alla storia come il “massacro di Halabja”, l’attacco con armi chimiche proibite dalla Convenzione di Ginevra avvenne tra il 16 e il 19 marzo 1988. Halabja (città della provincia di as-Sulaymaniya) era caduta il giorno prima, 15 marzo 1988, in mano alla formazione curda dell’UPK (Unione Patriottica Curda) guidata da Jalal Talabani.
Eravamo in piena guerra Iran-Iraq (avviata nel 1980) e, come è noto (vedi l’abbattimento da parte dell’Incrociatore USS Vincennes dell’Airbus A300 iraniano - 290 vittime tra cui 66 bambini - solo qualche mese dopo, in luglio) l’Occidente (o meglio: gli Stati Uniti) era all’epoca sostanzialmente schierato con Bagdad.
Il massacro di Halabja fu il risultato dell’impiego di gas chimici (gas mostarda) per ordine di Ali Hassan al-Majid (conosciuto come “Ali il Chimico”, poi condannato a morte e giustiziato). Per l’operazione genocida (inserita nella più vasta operazione Anfal, dal febbraio al settembre 1988) l’aviazione irachena si servì di caccia-bombardieri MiG-31 e Mirage. I morti accertati (tutti curdi) furono oltre cinquemila.
Una prima serie di attacchi aerei contro Halbja era già avvenuta dal 23 febbraio al 19 marzo 1988, quando la città era caduta in mano all’esercito iraniano.
Complessivamente l’operazione Anfal, ideata esplicitamente contro la popolazione curda, provocò la morte di circa 180mila persona e la distruzione del 90% dei villaggi curdi del Bashur (il Kurdistan posto all’interno dei confini iracheni). Oltre alla deportazione di gran parte dei curdi sopravvissuti.
Quindi, niente di nuovo sotto il sole iracheno, per quanto opacizzato dalle nubi dei gas. Anche recentemente (nei giorni 7,8 e 9 dicembre 2022 per la cronaca) si torna a parlare di gas chimici impiegati contro la Resistenza curda. Stavolta per mano della Turchia.
Ankara prosegue imperterrita nella brutale operazione di occupazione militare e rastrellamento (ai limiti della pulizia etnica) lanciata il 15 aprile. Operazione che ha visto (soprattutto in settembre) un ampio utilizzo di sostanze tossiche proibite dalla Convenzione di Ginevra.
Anche se, va detto, sembra incontrare non poche difficoltà come starebbero a dimostrare i video diffusi dalla guerriglia curda che appare in grado non solo di resistere, ma anche di infliggere duri colpi alle truppe di occupazione. In questo momento i combattimenti più aspri si starebbero svolgendo nella regione di Medya. Qui l’esercito turco cercherebbe di stanare la resistenza curda dalla vasta rete di grotte, anfratti e tunnel in cui trova rifugio tra i combattimenti. In particolare la zona di Çemço (dove la residenza è più consolidata) sarebbero stati colpiti con armi chimiche decine di volte nei giorni già citati (7, 8 e 9 dicembre ).
Gianni Sartori
Gianni Sartori - 11/12/2022 - 11:50
IRAN: NO ALLA PENA DI MORTE!
Gianni Sartori
La condanna a morte inflitta recentemente alla militante curda Pakhshan Azizi sta suscitando proteste nelle carceri iraniane
Nella serata di sabato 27 luglio le prigioniere politiche del carcere di massima sicurezza di Evin (a Teheran) si sono rifiutate di rientrare dal cortile nelle celle per protestare contro le condanne a morte e le esecuzioni. Scandendo alcuni slogan: “Abbasso il regime delle esecuzioni”. “Morte al dittatore”, “Libertà per le prigioniere politiche”, “No alle esecuzioni” e dichiarando che “i reparti femminili del carcere di Evin sono uniti, in piedi fino a quando la pena di morte sarà abolita”. Le prigioniere hanno rifiutato di lasciare il cortile della prigione per diverse ore, fino alla mattina successiva. Tra di loro anche la Premio Nobel per la Pace 2023 Narges Mohammadi, reclusa dal 2021.
Una risposta alla condanna inflitta recentemente (23 luglio) dal Tribunale “Rivoluzionario” Islamico alla giornalista curda Pakhshan Azizi ugualmente qui rinchiusa.
Provvisoriamente sospese durante il periodo elettorale, le esecuzioni sono riprese e almeno 18 detenuti sono stati uccisi tra il 21 e il 24 luglio.
Dal 30 luglio (martedì, spesso giorno prescelto per eseguire le condanne a morte) anche le prigioniere di Evin, a fianco delle detenute di un'altra quindicina di carceri iraniane, prendono parte alla campagna “No ai martedì delle esecuzioni” entrando in sciopero della fame.
Campagna che si svolge ormai per la ventisettesima settimana in una quindicina di prigioni.
Pakhshan Azizi è accusata di “insurrezione armata” (baghi) in quanto militante del Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê, (PJAK, Partito per la vita libera in Kurdistan).
Come aveva scritto in un comunicato del 24 luglio Narges Mohammadi “le donne del carcere di Evin dicono all'unisono che esigono la sospensione immediata dell'esecuzione di Pakshan Azizi. Ci rivolgiamo a tutti affinché uniscano la loro voce a quella delle prigioniere politiche e ideologiche”.
Nel frattempo sono rimaste inascoltate le richieste degli avvocati di Pakshan Azizi per incontrare la loro cliente
Cosi come da tre settimane sono state sospese le visite dei familiari (come ha denunciato Azo Azizi, fratello della militante curda condannata a morte).
Gianni Sartori
Gianni Sartori
La condanna a morte inflitta recentemente alla militante curda Pakhshan Azizi sta suscitando proteste nelle carceri iraniane
Nella serata di sabato 27 luglio le prigioniere politiche del carcere di massima sicurezza di Evin (a Teheran) si sono rifiutate di rientrare dal cortile nelle celle per protestare contro le condanne a morte e le esecuzioni. Scandendo alcuni slogan: “Abbasso il regime delle esecuzioni”. “Morte al dittatore”, “Libertà per le prigioniere politiche”, “No alle esecuzioni” e dichiarando che “i reparti femminili del carcere di Evin sono uniti, in piedi fino a quando la pena di morte sarà abolita”. Le prigioniere hanno rifiutato di lasciare il cortile della prigione per diverse ore, fino alla mattina successiva. Tra di loro anche la Premio Nobel per la Pace 2023 Narges Mohammadi, reclusa dal 2021.
Una risposta alla condanna inflitta recentemente (23 luglio) dal Tribunale “Rivoluzionario” Islamico alla giornalista curda Pakhshan Azizi ugualmente qui rinchiusa.
Provvisoriamente sospese durante il periodo elettorale, le esecuzioni sono riprese e almeno 18 detenuti sono stati uccisi tra il 21 e il 24 luglio.
Dal 30 luglio (martedì, spesso giorno prescelto per eseguire le condanne a morte) anche le prigioniere di Evin, a fianco delle detenute di un'altra quindicina di carceri iraniane, prendono parte alla campagna “No ai martedì delle esecuzioni” entrando in sciopero della fame.
Campagna che si svolge ormai per la ventisettesima settimana in una quindicina di prigioni.
Pakhshan Azizi è accusata di “insurrezione armata” (baghi) in quanto militante del Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê, (PJAK, Partito per la vita libera in Kurdistan).
Come aveva scritto in un comunicato del 24 luglio Narges Mohammadi “le donne del carcere di Evin dicono all'unisono che esigono la sospensione immediata dell'esecuzione di Pakshan Azizi. Ci rivolgiamo a tutti affinché uniscano la loro voce a quella delle prigioniere politiche e ideologiche”.
Nel frattempo sono rimaste inascoltate le richieste degli avvocati di Pakshan Azizi per incontrare la loro cliente
Cosi come da tre settimane sono state sospese le visite dei familiari (come ha denunciato Azo Azizi, fratello della militante curda condannata a morte).
Gianni Sartori
Gianni Sartori - 30/7/2024 - 16:26
ETNOCIDI IN CORSO:
PER COLPIRE UN POPOLO NIENTE DI MEGLIO CHE CANCELLARNE LA STORIA E DISTRUGGERE L'AMBIENTE
Gianni Sartori
Non è da oggi naturalmente. Già da qualche decennio le organizzazioni curde denunciano l'opera di devastazione ambientale, l'ecocidio sistematico operato dalle truppe turche in Kurdistan nell'ultimo secolo.
Del resto, come aveva scritto qualcuno “se vuoi eliminare un popolo, comincia con la sua storia e con la natura, distruggi l'ambiente e prendi tutto quello che ti serve” (cito a memoria).
Un metodo che Ankara, da paese occupante, sembra aver ben appreso e applicato. Aggiornandolo, soprattutto da quando è al potere l'AKP.
Qualche esempio. Con la diga di Ilisu sono stati irreparabilmente sommersi dalle acque i monumenti storici di Hasan Kaif, patrimonio storico dell'umanità (la città di Ayyubid viene considerata uno dei primi esempi di civilizzazione della Mesopotamia, oltre che importante centro degli imperi iraniano e romano e capitale religiosa).
Una cancellazione totale così come è accaduto per altri luoghi-simbolo.
Ancora più generalizzata la distruzione ambientale con l'incendio pianificato di foreste secolari.
Vedi nella zona di Mesila Kor (distretto di Lajja di Amid) dove, qualche anno fa, vennero abbattutti in pochi giorni oltre diecimila alberi. Stesso sradicamento (non solo in senso metaforico) a Mush, Basur e Dersim.
Uno strumento utilizzato dall'esercito turco sia per mettere in difficoltà la resistenza curda (le foreste forniscono un rifugio, già dai tempi di Robin Hood), sia come ritorsione, rappresaglia quando subisce una sconfitta.
Incendiando i boschi e impedendone lo spegnimento, non solo in Bakur e Bashur, ma anche nel nord della Siria.
Come in Afrin, sotto occupazione dal 2018 (operazione ironicamante denominata “Ramoscello d'ulivo”), dove sono stati tagliati e bruciati migliaia di ulivi. Rispondendo a una domanda dei rappresentanti di HDP, il ministro dell'Agricoltura turco, Bekir Pakdemirli, aveva ammesso che gli ulivi di Afrin venivano tagliati così come viene depredata la produzione di olive da esportare in Europa.
E, segnalavano fonti curde “come passa sotto silenzio la distruzione dell'ambiente e delle risorse di Afrin, così avviene per la distruzione delle foreste nel Kurdistan del Sud (Başûr Kurdistan, entro i confini iracheni)”.
Con l'approvazione di fatto del clan Barzani (dato che ciò avviene in territori posti sotto il controllo del PDK).
Tra gli ecocidi più devastanti, va ricordato il taglio di oltre 400 tonnellate di alberi sulle montagne Judi nel 2021.
Operazioni talvolta propedeutiche alla costruzione di sempre nuove basi militari turche in territorio iracheno.
Sempre nell'aprile 2021 altri devastanti incendi erano scoppiati a seguito dei bombardamanti effettuati con aerei (F-16), elicotteri da cobattimento e droni (Bayraktar TB2) sulle colline di Zindoora (distretto di Metina dove è insediata una base militare turca). Nel corso delle operazione delle forze speciali di Ankara denominate Pençe Şimşek (Artiglio lampo) e Pençe Yıldırım (Artiglio fulmine).
Stessa sorte subivano le popolazioni civili di Gilwi-Bjok (distretto di Zab) e i distretti di Marwanos e Shuk (Avashin).
Una autentica “soluzione finale” (con lo scopo dichiarato di spopolare l'area) per migliaia di ettari di terreni coltivati (orti, vigneti...) ridotti in cenere. A cui aggiungere la morte di un gran numero di animali.
A completare l'opera, migliaia di mercenari provenienti sia dalla Siria che dalla Libia vennero trasportati nella base di Barmeni. Altri alberi furono tagliati a migliaia sia a Zakho (dove con il permesso del Partito Democratico del Kurdistan si sono installate altre basi militari) che a Barwari. Per essere poi venduti come legname in Turchia, mentre - effetto neanche tanto collaterale – gli abitanti si trasformavano in sfollati (profughi interni).
E' poi di questi giorni la notizia che una nuova, l'ennesima, base militare turca è in costruzione in quel di Amadiya (Amêdî), sempre nel sud del Kurdistan (nord dell’Irak).
Situata nei pressi del villaggio di Guherzê (Guharz), viene a collocarsi sul fronte occidentale della regione di Zap, una roccaforte del PKK. Munita di rifugi e trincee, è destinata a ricoprire un ruolo fondamentale, strategico, nelle operazioni dell'esercito turco.
Contemporaneamente nell'area procedono i lavori per la realizzazione di una “strada militare di sicurezza” con la conseguenza di un'ampio squarcio disboscato nella foresta. Attività a cui – condizionale d'obbligo – parteciperebbero anche unità di peshmerga del PDK muniti di asce e seghe per aprire la strada alle ruspe.
Altri danni devastanti a boschi secolari, provocati dai bombardamenti, sono stati ben documentati da giornalisti indipedenti nella zona di Sergelê e di Medya (dove sono presenti i partigiani curdi).
Ancora più criminale l'uso – documentato – di armi chimiche (sempre nella zona di Medya), in teoria proibite dagli accordi internazionali a cui – sempre in teoria – aderisce anche al Turchia.
Spetta ai partigiani curdi il compito di preservare per quanto possibile l'ambiente, la natura, la biodiverstità del Kurdistan. Fondamantele per la sopravvivenza del loro stesso popolo.
Come aveva detto forte chiaro ancora nel 2014 (quando da Imrali usciva ancora qualche sua dichiarazione) Abdullah Ocalan: "Quando la natura del Kurdistan viene distrutta, dobbiamo intervenire per impedirlo. E' un principio fondamentale, un dovere e un privilegio, della politica democratica. Dobbiamo elaborare un modello alternativo a questa politica di sfruttamento”.
Gianni Sartori
PER COLPIRE UN POPOLO NIENTE DI MEGLIO CHE CANCELLARNE LA STORIA E DISTRUGGERE L'AMBIENTE
Gianni Sartori
Non è da oggi naturalmente. Già da qualche decennio le organizzazioni curde denunciano l'opera di devastazione ambientale, l'ecocidio sistematico operato dalle truppe turche in Kurdistan nell'ultimo secolo.
Del resto, come aveva scritto qualcuno “se vuoi eliminare un popolo, comincia con la sua storia e con la natura, distruggi l'ambiente e prendi tutto quello che ti serve” (cito a memoria).
Un metodo che Ankara, da paese occupante, sembra aver ben appreso e applicato. Aggiornandolo, soprattutto da quando è al potere l'AKP.
Qualche esempio. Con la diga di Ilisu sono stati irreparabilmente sommersi dalle acque i monumenti storici di Hasan Kaif, patrimonio storico dell'umanità (la città di Ayyubid viene considerata uno dei primi esempi di civilizzazione della Mesopotamia, oltre che importante centro degli imperi iraniano e romano e capitale religiosa).
Una cancellazione totale così come è accaduto per altri luoghi-simbolo.
Ancora più generalizzata la distruzione ambientale con l'incendio pianificato di foreste secolari.
Vedi nella zona di Mesila Kor (distretto di Lajja di Amid) dove, qualche anno fa, vennero abbattutti in pochi giorni oltre diecimila alberi. Stesso sradicamento (non solo in senso metaforico) a Mush, Basur e Dersim.
Uno strumento utilizzato dall'esercito turco sia per mettere in difficoltà la resistenza curda (le foreste forniscono un rifugio, già dai tempi di Robin Hood), sia come ritorsione, rappresaglia quando subisce una sconfitta.
Incendiando i boschi e impedendone lo spegnimento, non solo in Bakur e Bashur, ma anche nel nord della Siria.
Come in Afrin, sotto occupazione dal 2018 (operazione ironicamante denominata “Ramoscello d'ulivo”), dove sono stati tagliati e bruciati migliaia di ulivi. Rispondendo a una domanda dei rappresentanti di HDP, il ministro dell'Agricoltura turco, Bekir Pakdemirli, aveva ammesso che gli ulivi di Afrin venivano tagliati così come viene depredata la produzione di olive da esportare in Europa.
E, segnalavano fonti curde “come passa sotto silenzio la distruzione dell'ambiente e delle risorse di Afrin, così avviene per la distruzione delle foreste nel Kurdistan del Sud (Başûr Kurdistan, entro i confini iracheni)”.
Con l'approvazione di fatto del clan Barzani (dato che ciò avviene in territori posti sotto il controllo del PDK).
Tra gli ecocidi più devastanti, va ricordato il taglio di oltre 400 tonnellate di alberi sulle montagne Judi nel 2021.
Operazioni talvolta propedeutiche alla costruzione di sempre nuove basi militari turche in territorio iracheno.
Sempre nell'aprile 2021 altri devastanti incendi erano scoppiati a seguito dei bombardamanti effettuati con aerei (F-16), elicotteri da cobattimento e droni (Bayraktar TB2) sulle colline di Zindoora (distretto di Metina dove è insediata una base militare turca). Nel corso delle operazione delle forze speciali di Ankara denominate Pençe Şimşek (Artiglio lampo) e Pençe Yıldırım (Artiglio fulmine).
Stessa sorte subivano le popolazioni civili di Gilwi-Bjok (distretto di Zab) e i distretti di Marwanos e Shuk (Avashin).
Una autentica “soluzione finale” (con lo scopo dichiarato di spopolare l'area) per migliaia di ettari di terreni coltivati (orti, vigneti...) ridotti in cenere. A cui aggiungere la morte di un gran numero di animali.
A completare l'opera, migliaia di mercenari provenienti sia dalla Siria che dalla Libia vennero trasportati nella base di Barmeni. Altri alberi furono tagliati a migliaia sia a Zakho (dove con il permesso del Partito Democratico del Kurdistan si sono installate altre basi militari) che a Barwari. Per essere poi venduti come legname in Turchia, mentre - effetto neanche tanto collaterale – gli abitanti si trasformavano in sfollati (profughi interni).
E' poi di questi giorni la notizia che una nuova, l'ennesima, base militare turca è in costruzione in quel di Amadiya (Amêdî), sempre nel sud del Kurdistan (nord dell’Irak).
Situata nei pressi del villaggio di Guherzê (Guharz), viene a collocarsi sul fronte occidentale della regione di Zap, una roccaforte del PKK. Munita di rifugi e trincee, è destinata a ricoprire un ruolo fondamentale, strategico, nelle operazioni dell'esercito turco.
Contemporaneamente nell'area procedono i lavori per la realizzazione di una “strada militare di sicurezza” con la conseguenza di un'ampio squarcio disboscato nella foresta. Attività a cui – condizionale d'obbligo – parteciperebbero anche unità di peshmerga del PDK muniti di asce e seghe per aprire la strada alle ruspe.
Altri danni devastanti a boschi secolari, provocati dai bombardamenti, sono stati ben documentati da giornalisti indipedenti nella zona di Sergelê e di Medya (dove sono presenti i partigiani curdi).
Ancora più criminale l'uso – documentato – di armi chimiche (sempre nella zona di Medya), in teoria proibite dagli accordi internazionali a cui – sempre in teoria – aderisce anche al Turchia.
Spetta ai partigiani curdi il compito di preservare per quanto possibile l'ambiente, la natura, la biodiverstità del Kurdistan. Fondamantele per la sopravvivenza del loro stesso popolo.
Come aveva detto forte chiaro ancora nel 2014 (quando da Imrali usciva ancora qualche sua dichiarazione) Abdullah Ocalan: "Quando la natura del Kurdistan viene distrutta, dobbiamo intervenire per impedirlo. E' un principio fondamentale, un dovere e un privilegio, della politica democratica. Dobbiamo elaborare un modello alternativo a questa politica di sfruttamento”.
Gianni Sartori
Gianni Sartori - 20/11/2024 - 11:18
×
![]()
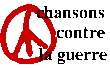






Wild Geese
L'Attacco chimico di Halabja (in curdo: Kîmyabarana Helebce) avvenne il 16 marzo 1988, durante la guerra Iran-Iraq. Armi chimiche furono utilizzate dall'esercito iracheno nella città curda di Halabja.
L'attacco fu realizzato con gas al cianuro per rappresaglia contro la popolazione curda che non aveva frapposto sufficiente resistenza al nemico iraniano. I morti furono circa 5000. I Curdi morti in totale furono più di 100.000.
In seguito a questa azione tra il 2007 ed il 2008 vennero processati per crimini contro l'umanità vari gerarchi del regime di Saddam Hussein (ma non quest'ultimo, all'epoca già impiccato per altri crimini), tra cui il comandante militare delle operazioni, Ali Hassan Abd al-Majid al-Tikritieh], che venne condannato a morte, sentenza eseguita il 25 gennaio 2010.
wikipedia
Tutto accadde durante la guerra Iraq-Iran, conosciuta da molti come guerra del Golfo (Persico). Il 16 marzo 1988 nella città di Halabaja - città di circa 70mila abitanti situata nel Kurdistan iracheno, a 240 km a nordest di Baghdad e a 15 km dal confine iraniano - il regime iracheno, guidato all'epoca dal dittatore Saddam Hussein, compì un orrendo massacro. Per diverse ore l'aviazione dell'Iraq bombardò le zone residenziali della città con un composto chimico letale - un miscuglio di iprite, acido cianidrico e gas neurotossici.
In quell'attacco persero la vita almeno 12mila persone, mentre i sopravvissuti dovettero lottare anche a distanza di anni contro diverse malattie e disturbi fisici (si registrò un'impennata di casi di cancro al colon, di problemi cardiaci e respiratori, di tumori della pelle e di problemi alla vista). Inoltre nell'area si riscontrarono diversi casi di malformazione genetica.
Nonostante oggi quest'episodio viene da tutti riconosciuto come un crmine contro l'umanità, all'epoca la comunità internazionale non mosse un dito contro l'Iraq - allora alleato degli Stati Uniti -, dimenticandosi di applicare le sanzioni previste dal capitolo 7 della Carta Onu, lo stesso usato dal governo britannico per ricevere dal Consiglio di sicurezza l'autorizzazione per intervenire in Siria. Il dipartimento di stato americano non perse tempo e il giorno dopo accusò l'Iran per quanto fosse accaduto, argomentazioni che vennero portate avanti anche dalla CIA per buona parte degli anni 90. L'agenzia di intelligence statunitense cambiò poi radicalmente versione qualche anno più tardi e citò spesso il caso Halabja per dimostrare il possesso di armi chimiche da parte del regime di Hussain e giustificare l'intervento militare.
Armi chimiche vennero usate dall'Iraq qualche mese più tardi, dopo che venne siglato l'accordo di cessare il fuoco con l'Iran. Il 25 agosto 1988, durante l'operazione "final Anfal", il regime iracheno attaccò la regione kurda del Baldian facendo largo uso di iprite e gas nervino. Gli attacchi andarono avanti fino al 9 settembre, quando il regime fu costretto a intettormpere la sua "soluzione finale" per le forte proteste internazionali. Durante quei giorni persero la vita numerosi civili; alcuni riuscirono invece a rifugiarsi nei territori vicini, per lo più in Turchia. Anche in questo frangente l'Onu non fece nulla per accorrere in aiuto della popolazione, perché "si trattava di una questione interna dello stato iracheno".
Per quale ragione quindi la comunità internazionale non ci sta pensando due volte a intervenire in Siria (nonostante non siano state ancora mostrate prove certe) mentre non fece quasi nulla per il caso curdo? Forse le Nazioni Unite hanno imparato molto dalle dure lezioni del passato, oppure i regolamenti internazionali e la Carta dell'Onu valgono veramente poco di fronte agli interessi strategici dei paesi del blocco Atlantico
ibtimes.com