Una sera, al termine di uno dei miei spettacoli, una giornalista mi ha rivolto questa domanda: «Cosa vuol dire teatro narrativo civile?».
Non deve aver dormito tutta la notte. Certi giornalisti sono così.
E’ come chiedere ad un pasticcere “Cosa vuol dire fare i pasticcini”?, oppure ad un falegname “Cosa vuol dire fare i tavoli?”
Certi giornalisti non ce la fanno.
Comunque io ci ho pensato, e gli ho risposto attraverso una storia.
Accadeva molti anni fa dalle mie parti, sull’ appennino tosco-emiliano, non lontano da Monte Sole e Marzabotto, di sera. Tutti i sabati andava in scena la saga del gnocco fritto. Avete presente la pasta del pane fritta?
La tavola era imbandita, la nonna era in cucina e preparava il gnocco.
Noi invece eravamo una brigata di rompicoglioni, correvano e gridavano.
Intanto gli uomini giocavano a carte e non facevano un beato cazzo di niente.
Il camino era sempre acceso e si sentiva un forte odore di legna bruciata.
E al nonno dicevamo: “siamo in agosto e siamo sudati come dei maiali, dobbiamo tenere sempre acceso sto’camino?”.
E lui urlava come un pazzo: “No, deve essere acceso perché la legna è come le nostre parole”.
Allora a nostra madre chiedevamo se ci fosse uno bravo, ma veramente molto bravo a curare il nonno.
A un certo punto la nonna e le altre donne portavano enormi vassoi: il gnocco fumava, c’erano porzioni abbondanti di salumi e formaggi, enormi bacili di insalata, il pane appena sfornato.
Il nonno usciva lento dalla cantina, aveva tra le mani due bottiglie di vino rosso.
Poi si sedeva a capo tavola. E noi alzavamo sempre più la voce, indisciplinati, rompicoglioni, come quelle moschine che d’estate non ti danno pace, che ti scivolano in bocca mentre tu sei lì sul divano a dormire:
Del resto per essere dei rompicoglioni con la patente da rompicoglioni bisogna mettercela tutta, soprattutto bisogna avere un nemico.
E il nostro nemico era il nonno, era perfetto.
Appena finito di mangiare il nonno si alzava dalla sedia e si piazzava in un divano vicino al fuoco, gli uomini sparecchiavano, le donne lavavano i piatti. Il nonno accendeva la pipa, poi prendeva un bicchiere e si versava la grappa, guardava noi e, con voce forte, diceva: «Allora…».
Il nonno si metteva davanti al camino e si faceva illuminare dal fuoco come Marlon brando in Apocalypse Now, quando continuava a ripetere la stessa frase: “orrore…orrore”.
E noi dicevamo: “Nonno adesso ci fai paura”..
Iniziava così una storia del passato, quando sul crinale dell’ appennino si combatteva una guerra. Prato liberata dagli americani, Bologna ancora in mano ai nazifascisti, e in mezzo c’erano i partigiani del gruppo Stella Rossa.
E dicevamo: “Nonno, ma è possibile che con tutte le storie che finiscono bene, che ce ne sono tante, sempre quella che finisce con i bambini fucilati?”.
Il nonno andava avanti con il suo racconto.
Descriveva in modo minuzioso le serate a lume di candela passate ad ascoltare clandestinamente i messaggi in codice di Radio Londra, lo scalpiccio di stivali dei soldati nazisti sulla ghiaia delle strade di Marzabotto e di Montesole, fuori dalle case, il vento forte che passava tra i vetri, gli spari, le urla, la morte.
Il nonno raccontava di quando i soldati nazisti della 16esima divisione PanzerGranadier circondarono una vasta area tra i fiumi Reno e Setta. Mentre salivano bruciavano le case, le persone che uscivano venivano trucidate davanti all’uscio. E poi non era finita. Perché le persone impaurite risalivano il monte verso San Martino, verso la chiesa di Casaglia.
Lì il maggiore Walter Reder detto il monco ordinò ad un soldato di entrare nella chiesa e uccidere il parroco Don Ubaldo Marchionni. E poi non era ancora finita. I fedeli uscivano dalla chiesa e si trovavano davanti i mitragliatori. Qualche ragazzino si lanciò nel dirupo o si nascose nei cespugli. Altri vennero accompagnati al cimitero di Casaglia dove, se andate e portate i vostri figli, troverete delle croci di ferro bucate da pallottole a venti centimetri, per colpire i bambini che si nascondevano dietro ai corpi dei loro genitori.
Ma alcune volte il nonno si dimenticava se la sera prima di quel…29 settembre 1944 c’erano le stelle oppure pioveva, tanto che dicevamo: “nonno, facciamo così, fai un’assemblea con te stesso, nomina una maggioranza e un’opposizione, poi ci dici se il 28 settembre 1944 c’erano le stelle oppure pioveva”
Ogni sera la storia che il nonno raccontava era così uguale ma così diversa.
C’era sempre un elemento in più che rendeva il suo racconto affascinante e mai noioso: un taglio di luce particolare, un gioco di ombre, un temporale, il chiarore delle stelle, un odore, soprattutto la passione. Fino a quando quelle storie saranno raccontate alle generazioni future ci sarà memoria. Se il filo si spezza, si perde la conoscenza del passato, non si comprende il presente e non si potrà vivere il futuro.
Ecco perché anche noi questa sera facciamo teatro e musica d’impegno civile.
Per non dimenticare.
24 luglio 1943, ore 17: inizia la riunione del Gran Consiglio del Fascismo, organismo costituzionale e direttorio politico del Partito Nazionale Fascista, Alle 3 di notte del 25 luglio, viene approvato l’ordine del giorno dei gerarchi Giuseppe Bottai, Dino Grandi e Galeazzo Ciano, prevede la restituzione dell’alto comando al Re. Benito Mussolini viene destituito e subito arrestato.
25 luglio, ore 22:45: il popolo italiano apprende dalla radio che il Re ha assunto il comando supremo delle Forze Armate e il piccolo maresciallo Pietro Badoglio il governo militare del paese con pieni poteri. Poco dopo il piccolo Badoglio indica già le sue prime direttive. Non so se avete presente, il piccolo Badoglio che detta le sue condizioni:
«… la guerra continua e l’Italia resta fedele alla parola data… chiunque turbi l’ordine pubblico sarà inesorabilmente colpito».
Benito Mussolini, ormai ridotto a un ducetto, viene trasferito per tre giorni alla caserma della Legione Allievi Carabinieri, nel quartiere Prati di Roma. Poi spostato via mare nelle isole di Ventotene, Ponza, Maddalena. Infine, rinchiuso in una cella a Campo Imperatore, sorvegliato da duecentocinquanta uomini tra carabinieri e guardia di finanza.
Ovunque, nelle città e nei paesi, manifestazioni di piazza salutano la caduta del regime fascista.
8 settembre 1943, ore 19:45: dopo cinque giorni di lunghe ed estenuanti trattative, il piccolo Pietro Badoglio annuncia l’armistizio dai microfoni dell’E.I.A.R.:
«Il governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di continuare l’impari lotta contro la schiacciante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi danni alla nazione, ha chiesto l’armistizio al generale Eisenhower… La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza».
Roba da duri, gente con le palle, gente che non ha paura, che sfida il nemico a testa alta, direte voi. E invece…..
9 settembre, ore 5,10
Come fanno i topi, presto, di mattina, il Re, la famiglia reale e Pietro Badoglio, seguiti da un corteo di miracolati, composto da generali e funzionari, abbandonano Roma, diretti a Pescara, dove li attende una corvetta che li trasporta in Puglia.
L’Italia è ormai occupata da ore dai nazisti.
L’esercito regolare muore schiacciato da una guerra più grande delle sue possibilità militari, lasciato a sé stesso nelle ore dell’agonia, dal Re e dal comando supremo militare.
Gli ufficiali di professione attendono ordini che non arriveranno mai.
I soldati sfondano le porte, escono dalle camerate, abbandonano le caserme, le armi pesanti e leggere, tutti i loro mezzi, barattano per pochi soldi ogni abito borghese, ogni via di scampo, ogni ritorno a casa.
L’Italia si trasforma in un’immensa retrovia dove i soldati fuggono e si nascondono nelle case di famiglia, nei boschi, nelle valli, tra sentieri impervi, piccoli borghi e rifugi di montagna.
Il governo regio fuggiasco a Brindisi crede di poter tornare entro pochi giorni a Roma alla guida del paese, ma le quattordici divisioni della Seconda e Ottava Armata italiana si sciolgono al confine orientale, il corpo motocorazzato schierato a difesa della Capitale si arrende, della Settima Armata si salvano solo le divisioni raggiunte dalle truppe inglesi.
Intanto il feldmaresciallo Erwin Rommel liquida le nostre armate al Nord, il feldmaresciallo Albert Keserling quelle del Sud, mentre si oppone alle forze anglo-americane, sbarcate a Salerno e Taranto.
E allora?
Che si fa quando tutto sembra perduto?
Quando non si vede nemmeno l’ultimo spiraglio di luce?
Quando intorno c’è il buio del terrore e dell’occupazione?
E allora che si fa ?
E allora inizia la Resistenza.
La guerra dell’Italia partigiana incomincia proprio quando termina la guerra del regime.
L’armata ribelle si forma dopo la disfatta di quella regia e fascista.
Certo, all’inizio sono poche migliaia di persone.
Di notte, qualcuno a Cuneo nota ombre che scivolano lungo i muri delle caserme, fino alle finestre delle armerie.
Sono Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Benedetto Dalmastro che prendono le armi.
Saranno l’avanguardia del movimento di Giustizia e Libertà nel cuneese.
In certi luoghi di montagna mentre scendono a valle i soldati dell’esercito in rotta, risalgono gruppetti di studenti universitari, operai delle fabbriche delle città, ufficiali del corpo degli alpini, intellettuali, scrittori, giornalisti, professionisti affermati, contadini,
“Dove andate? – Andiamo in montagna a riprenderci le vostre posizioni. Venite con noi?”
La minoranza del settembre 1943 è l’avanguardia di una Resistenza che ha radici lontane: nelle fabbriche, nei campi, nelle scuole, nelle prigioni, tra i fuoriusciti in Francia e i confinati a Ventotene, fin dentro l’esercito fascista.
13 settembre 1943: la radio tedesca annuncia la liberazione di Benito Mussolini dalla sua prigione, un albergo sul Gran Sasso d’Italia. Il giorno dopo il Duce va a Rastenburg, in Germania, in aereo. Hitler lo attende davanti al bunker. Mussolini è nelle sue mani, il Führer è il suo padrone politico e militare. Il Duce è ormai un fantoccio del Terzo Reich.
18 settembre 1943: da Radio Monaco, Benito Mussolini riprende le redini del “nuovo fascismo” nato sotto l’ombrello nazista:
«Riprendere le armi a fianco della Germania e del Giappone, nostri alleati… preparare senza indugio le nostre Forze Armate attorno alle formazioni della Milizia… eliminare i traditori…».
Nell’Italia occupata dai nazisti nasce la Repubblica Sociale Italiana.
Da una parte si schierano i soldati della repubblichina, dall’altra prendono forma le bande partigiane.
I ribelli si posizionano dove possono, dove ci sono montagne, colline, boschi, e nelle scuole e fabbriche delle città, praticamente dappertutto.
I loro numero cresce gradualmente nei mesi della lotta di Liberazione: 2mila (settembre 1943), 4mila (novembre 1943), 25mila (aprile 1944), 80mila (marzo 1945), 130mila (inizio aprile 1945), 250mila (fine aprile 1945).
Per i ribelli saranno anni lunghi, difficili, febbrili.
Prendere armi, sotterrare armi dappertutto: nei boschi, nelle baite, di montagna, negli scantinati dei palazzi delle città, perfino nelle tombe dei piccoli cimiteri.
Trasportare armi con carri riempiti di segatura, coperti di fascine, di fieno.
Prendere farina, lardo, pane, benzina.
Scambiare sale con olio e olio con munizioni.
Cercare vestiti, scarpe, calzettoni di lana, tagliare legna, cuocere cibo per centinaia di persone, fabbricare letti con tronchi di pino e sacchi di paglia e di foglie, curarsi dalla scabbia, dai pidocchi.
Sparare precisi senza consumare colpi inutili, tenere le armi in sicurezza, abbandonare e conquistare postazioni, fuggire da attacchi improvvisi del nemico, sganciarsi dai rastrellamenti, lanciarsi in dirupi scoscesi, in riddani bui e spaventosi, con zaini pesanti, sotto piogge torrenziali, nevicate, sotto il caldo sole di agosto.
Fare i turni di notte in mezzo alla nebbia fitta, ascoltare i rumori dei boschi, dove anche il più impercettibile fruscio può rappresentare un pericolo, girare radenti ai muri delle case, mischiarsi alla folla delle piazze delle città.
Stampare giornali clandestini, distribuirli attraverso camioncini coperti da cassette di frutta e verdura, sporte delle donne, carrozzelle dei bambini, tricicli da negozio.
E ancora comprendere il linguaggio della povera gente, capire i loro bisogni, i dialetti, la psicologia della montagna, gli sguardi solitari dei montanari.
E decifrare i segreti di città grigie, morte quando scende la sera ed entra in vigore il coprifuoco, dove per le strade si incontrano solo le pattuglie tedesche e fasciste e le loro camionette.
E infine vivere nel silenzio di case senza acqua, luce, riscaldamento, in città dove le razioni delle tessere annonarie sono appena al livello della mera sussistenza, dove ci si muove di notte come gatti tra migliaia di case distrutte dai bombardamenti e di giorno nella paura di essere arrestati, incarcerati, torturati, fucilati senza alcun avvocato che ti difende e senza alcun processo.
Nel 1944 l’Italia del Nord era tutta occupata dai nazisti e dai repubblichini.
In autunno, si concentrano nelle Langhe qualcosa come 15mila partigiani.
Arrivano da tutte le parti, un vero e proprio esercito.
Ci sono le Brigate Garibaldi con i fazzoletti rossi, ci sono le formazioni autonome di Mauri, del Capitano North.
I partigiani mandano i preti a trattare con i fascisti.
“Quelli sono quindicimila, voi neanche 5 mila, se scendono dalle montagne vi fanno un mazzo così”.
I fascisti sgomberano Alba e sanno che torneranno.
I partigiani scendono dalle colline e occupano Alba e sanno che dureranno poco.
Ma devono farlo.
Devono dimostrare che possono governare anche una grande città. E non importa se la perderanno perché il futuro sarà quello dei partigiani, non quello dei fascisti e nazisti.
Così Beppe Fenoglio descrisse “I ventitré giorni della città di Alba”
……Stavolta c’erano, proprio di fronte, e si tirarono su dalla molle terra e spararono con tutte le armi, avendo i mirini accecati dal fango. Ora finalmente si vedevano, verdi e lustri come ramarri, ognuno col suo bravo elmetto, e il primo doveva essere un ufficiale, stava tutto diritto e si passava una mano sul viso per toglierne la pioggia. Un attimo dopo, era ancora diritto, ma le sue due mani non gli bastavano più per tamponarsi il sangue che gli usciva da parecchi punti della divisa.
C’erano di qua mitragliatrici americane e di là tedesche, e insieme fecero il più grande e lungo rumore che la città di Alba avesse sino allora sentito. Per circa quattro ore, per il tempo cioè che i partigiani tennero San Casciano, fischiò nei due sensi un vento di pallottole – che scarnificò tutti gli alberi, stracciò tutte le siepi, spianò ogni canneto, e fece naturalmente dei morti, ma non tanti, una cifra che non rende neanche lontanamente l’idea della battaglia.
Così, dalle sette fino alle undici passate, quei dilettanti della trincea inchiodarono i primi fucilieri della repubblica, uomini che sbalzavano avanti e poi s’accucciavano e viceversa a trilli di fischietto, assaltatori ammaestrati.
Un po’ dopo le undici, in un riposo che sembrava si fossero preso i fascisti, quelli giù a San Casciano videro affacciarsi tra gli alberi di Castelgherlone un partigiano, e verso di loro faceva con le braccia segnali disperati. Come vide che da basso non lo capivano, si scaraventò giù per il pendio mentre, forse per fermare proprio lui, i fascisti riprendevano a sparare. Quel partigiano arrivò scivoloni nel fango e disse che la repubblica, visto che al piano non passava, s’era trasportata in collina, in faccia a Castelgherlone, preso il quale, avrebbe aggirato dall’alto San Casciano. Portarsi tutti in collina e spicciarsi, adunata a Cascina Miroglio, perché Castelgherlone l’abbandonavano a momenti. Lui tornò su, i partigiani saltarono fuori dalla trincea, sgambavano già nel fango verso la collina senza aspettarsi l’un l’altro, a certuni scivolavano dalle spalle le cassette delle munizioni e non si fermavano a raccoglierle, quelli che seguivano facevano finta di non vederle.
Il pendio di Cascina Miroglio è ben erto, i piedi sulla terra scivolavano come sulla cera, unico appiglio l’erba fradicia. Qualcuno dei primi scivolò, perse in un attimo dieci metri che gli erano costati dieci minuti, finiva contro le gambe dei seguenti oppure questi per scansarlo si squilibravano, cosi ricadevano a grappoli improperandosi. Qualcuno, provatosi tre o quattro volte a salire e sempre riscivolato, scappò per il piano verso la città e fu perso per la difesa.
Arrivarono sull’aia della cascina vestiti e calzati di fango. A Cascina Miroglio c’era il Comandante la Piazza, un telefono da campo che funzionava e i mezzadri inebetiti dalla paura che porgevano macchinalmente secchi d’acqua da bere.
Marciando piegati in due arrivarono per la vigna gli uomini della mitragliera di Castelgherlone. Ma la grande arma non veniva con loro, l’avevano lasciata perché le si era rotto un pezzo essenziale. Gli altri, a quella vista, si sentirono stringere il cuore come se, girando gli occhi attorno, si fossero visti in cento in meno.
Era mezzogiorno, chi s’affacciò colle armi alle finestre, chi si postò dietro gli alberi, altri fra i filari spogli della vigna. E spararono alla repubblica quando sbucò dal verde di Castelgherlone. Piombò una mortaiata giusto sul tetto e il comignolo si polverizzò sull’aia. Un partigiano venne via dalla finestra per andare a raccogliere sul pavimento la mezzadra che c’era cascata svenuta.
Difesero Cascina Miroglio e, dietro di essa, la città di Alba per altre due ore, sotto quel fuoco e quella pioggia. Ogni quarto d’ora l’aiutante si staccava dal telefono e si sporgeva a gridare: – Tenete duro che vi arrivano i rinforzi! – Ma fino alla fine arrivarono solo per telefono.
In quel medesimo giorno, a Dogliani ch’è un grosso paese a venti chilometri da Alba, c’era la fiera autunnale e in piazza ci sarà stato un migliaio di partigiani che sparavano nei tirasegni, taroccavano le ragazze, bevevano le bibite e riuscivano con molta facilità a non sentire il fragore della battaglia di Alba.
Che così fu perduta alle ore due pomeridiane del giorno 2 novembre 1944.
Fu il Comandante la Piazza a dare il segno della ritirata, sparò un razzo rosso che descrisse un’allegra curva in quel cielo di ghisa. Parve che anche i fascisti fossero al corrente di quel segnale, perché smisero di colpo il fuoco concentrato e lasciavano partire solo più schioppettate sperse.
Tutti avevano già spallato armi e cassette, ma non si decidevano, vagabondavano per l’aia, al bello scoperto. Pensavano che Alba era perduta, ma che faceva una gran differenza perderla alle tre o alle quattro o anche più tardi invece che alle due. Sicché il Comandante fu costretto a urlare: – Ritirarsi, ritirarsi o ci circondano tutti! – e arrivava di corsa alle spalle dei più lenti, come fanno le maestre coi bambini delle elementari.
Scesero la collina, molti piangendo e molti bestemmiando, scuotendo la testa guardavano la città che laggiù tremava come una creatura.
Qualcuno senza fermarsi raccattò una manata di fango e se la spalmò furtivamente sulla faccia, come se non fossero già abbastanza i segni che era stata dura. È che la via della ritirata passava per dove la città dà nella campagna: li c’erano ancora molte case e si sperava che ci fosse gente, donne e ragazze, a vederli, a vederli cosi. Ma quando vi sbucarono, nel viale del Santuario quant’era lungo non c’era anima viva, e questo fu uno dei colpi più duri di quella terribile giornata. Soltanto, da una portina uscì una signora di più di cinquant’anni, al vederli scoppiò a piangere e diceva bravo a tutti man mano che la sorpassavano, finché da dietro un’imposta il marito la richiamò con una voce furiosa.
Tagliarono il viale del Santuario e andando contro l’acqua che ruscellava giù per la stradina, attaccarono a salire la collina di Belmondo che è il primo gradino alle Langhe. A mezza costa si fermarono e voltarono a guardar giù la città di Alba. Il campanile della cattedrale segnava le due e dieci. Gli arrivò fin lassù un rumore arrogante, guardando a un tratto scoperto di via Piave videro passarci due carri armati, e poi altri due, ciascuno con fuori dell’orlo una testa con casco. Oh guarda, così avevano i carri e non li hanno nemmeno adoperati.
I partigiani ripresero a salire, era spiovuto, i fascisti entrarono e andarono personalmente a suonarsi le campane.
Così andò a finire la battaglia di Alba.
Il 2 novembre 1944.
Dal 1943 al 1945, l’Italia occupata dai nazisti diventa un enorme mattatoio dove gli oppositori al regime fascista vengono arrestati illegalmente dalle polizie ufficiali, da quelle segrete, dalle tante compagnie di ventura disseminate nella Repubblica Sociale Italiana.
Partigiani ed ebrei vengono trasferiti in via Tasso a Roma, a Villa Triste a Firenze, in via Bolognese 67, a Villa Fossati a Milano in via Paolo Uccello 15, a Trieste in un edificio di via Bellosguardo, a Genova alla Casa dello Studente, a Biella a Villa Schneider.
E ancora trascinati negli scantinati di palazzi, retrobottega di negozi, rinchiusi in pensioni anonime come Oltremare in via Principe Amadeo 2 e Jaccarino in via Romagna a Roma, trasformati in luoghi di detenzione come il palazzo Carmagnola di via Rovello a Milano, dove la tortura è una pratica sistematica per i prigionieri.
Contro gli antifascisti si specializzano i peggiori aguzzini.
Sono i sanguinari delle strutture degli apparati dello Stato della RSI, gli assassini delle compagnie di ventura, i contabili della morte del fascismo.
C’è l’Esercito Nazionale Repubblicano con la Guardia nazionale Repubblicana di Renato Ricci e le Brigate nere di Alessandro Pavolini, segretario del Partito Fascista Repubblicano.
Ci sono i militari della Legione SS Italiana, unità affiliata alle Waffen SS alle dipendenze di Karl Wolf.
Ci sono i battaglioni operativi della Xmas di Junio Valerio Borghese.
C’è il raggruppamento paracadutisti Nembo.
A Roma in via Tasso, i fascisti collaborano con Herbert Kappler e la sua Sicherheitdienst polizei, SIPO.
A Firenze è operativa la 92esima legione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, la banda di Mario Carità.
A Trieste lavora l’ Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza per la Venezia Giulia.
A Cuneo e a Milano è attiva la Legione Autonoma Mobile Ettore Muti di Franco Colombo.
E sempre nella capitale della Resistenza arriva da Roma Pietro Koch, l’allievo che supera il maestro Mario Carità.
Pietro Koch ha il crimine nel sangue.
Fonda una sua banda, Così la banda Koch.
Vi aderiscono i preti Pasquino Perfetti e Ildefonso Troya, l’avvocato Augusto Trinca Armati, il giornalista Vito Videtta, gli attori Luisa Ferida e Osvaldo Valenti, l’esperto dei servizi segreti Francesco Argentino, il vice comandate operativo Armando Tela, il conte Guido Stampa, Alba Cimini, Marcella Stopponi, la soubrette Daisy Marchi, Lina Zini, Camilla Giorgiatti, gli agenti Cabruccio Cabrucci, Nestore Santini, Francesco Belluomini, Vito Videtta, l’ex gappista Guglielmo Blasi e altri.
La banda Koch è una confluenza di psicopatici, mitomani, sadici, degenerati, criminali comuni, cocainomani, esaltati, prostitute, delatori, spie.
La carovana della morte, il Reparto Speciale di Polizia guidato da Pietro Koch scivola lungo l’Italia come serpe affamata, cerca uomini e donne con idee diverse per placare la sua sete di sangue.
Il Reparto Speciale di Polizia entra nelle loro case.
Li stana come animali braccati: incatena le loro mani.
Mani grosse.
Non affusolate e ben curate come quelle degli aguzzini, ma mani da macellai, enormi.
Mani di contadini rugose, screpolate.
Mani di meccanici, sempre un po’ macchiate d’olio esausto.
Mani di donne giovani, ma già abituate a tirar su tre figli: mani forti per non crescere delinquenti, mani delicate per non lasciarli in balia della notte, svegli.
Mani di lavoratori che non hanno orario se non seguire la luce del giorno e l’oscurità della notte.
Mani callose di falegnami.
E poi ancora.
Mani di elettricisti coi capelli lunghi tenuti legati dietro la testa.
Mani di operai e manovali capaci di alzare 150 chili senza la paura di cadere sfiniti.
Mani di carta vetrata, con la polvere che è ormai tutt’uno con la pelle, sono le mani dei minatori di pietre che feriscono talvolta.
E tuttavia non fanno male come le bastonate che schioccano quei vigliacchi in guanti neri o guanti bianchi.
Aguzzini le cui mani sotto la pregiata stoffa che le nasconde sono rosse di sangue altrui, incancrenite di dolore appiccicato per sempre, eterna condanna.
Una volta che ha completato il carico, la carovana della morte, il Reparto Speciale di Polizia riprende il suo viaggio per giungere alla destinazione finale.
Quando gli aguzzini di Pietro Koch entrano nelle case di antifascisti ed ebrei tutti rubano i loro averi.
Poi trasferiscono i detenuti nelle camere di sicurezza.
Le persone arrestate vengono fatte oggetto di sevizie particolarmente efferate: formidabili pugni, schiaffi, calci, colpi inferti mediante bastoni di legno e di ferro, anche a spirale intrecciata e retrattili, frustini, nervi di bue, fustigazione dei testicoli.
I detenuti vengono portati in una cella detta carbonaia, richiusi in un pertugio detto buco, legati in due l’uno all’altro e appesi per giorni senza mangiare.
Alcuni sono costretti a pulire il pavimento dal proprio sangue con i gomiti.
Altri vengono trasportati per le scale tenendoli per i piedi così che il capo batte ogni scalino.
Colpi fortissimi vengono inferti alla regione cardiaca e al centro dello stomaco, oppure dritti contro gli occhi e le orecchie per provocare cecità e sordità, oppure ancora colpi alla mascella diretti a svellere i denti.
Ad altri ancora viene applicato alla fronte un semicerchio di ferro con due punte alle tempie oppure un telaio in legno che comprime il corpo umano contro una striscia chiodata.
Per i detenuti si alternano docce gelide e bollenti, gelide e bollenti, gelide e bollenti, così per ore, che diventano ore.
Tortura per estorcere informazioni preziose, per demolire la dignità delle persone, per ucciderle…
Ma non subito… no…
Poco alla volta…
Gli aguzzini ne studiano di notte e di giorno… bisogna esserci portati… non si possono compiere certi atti efferati e magari poi tornare a casa, baciare i propri figli come se nulla fosse successo…
Non puoi dire che torturi solo per il piacere di veder soffrire vite umane…
Torturi perché vuoi annullare ogni possibilità di opporsi ad un sistema che tu stesso hai costruito.
Non é una follia patologica, è una lucida consapevolezza.
Case anonime, garage, ville che si trasformano in centri di detenzione.
Luoghi di tortura dove si entra e non si esce vivi.
Gli stessi che anni dopo sono apparsi in Cile durante la dittatura di Augusto Pinochet (Villa Grimaldi), in Argentina durante la repressione contro gli oppositori ordinata dai generali Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Leopoldo Galtieri, Roberto Eduardo Viola (Garage Olimpo, Esquela de Mecànica de l’Armada), e i ogni luogo del mondo dove i diritti dell’uomo vengono calpestati da soldati e polizie segrete.
Ora se credi ti possa esser bastato
Voglio che mi accompagni fino in fondo alla caina
Là dove l’uomo non è mai arrivato
Là dove vi è la disumana violenza e la rovina.
Qui l’arte non riesce più a sostenere
La metafora, l’immagine, il suono dell’abisso
Perché il confine non lo puoi oltrepassare
Perché laggiù l’uomo, non è più uomo: è crocifisso.
Le menti lucide di carnefici senza ritegno
Annullano il concetto primitivo di razza umana
Non riesco più a pensare, abbasso gli occhi e mi sdegno
Di fronte ad un boia ancor più feroce di una mammana.
Cosa può esserci di più tremendo di violenta morte?
Cosa si può immaginare che superi qualsiasi aberrazione?
Apri gli orecchi quel che sto per dirti è veramente troppo forte
E se vuoi andartene, fallo ora, è la tua ultima occasione.
Per dirti quello che ti ho detto non ho usato mezze parole
Perché se dici di appartenere al genere umano
È ora di illuminare la coscienza con il sole
È ora di gridare, agire e fare un gran baccano.
Chino il capo come uomo abbattuto da altro uomo
Non chiedo perdono per i boia degli abissi
Taccio, ma non sarò mai domo
E griderò con tutta la mia rabbia e con gli occhi vergognosi e bassi
Che ormai il tempo della giustizia è tramontato
Questo è il tempo della verità e dei grandi passi.
Come ricordare oggi i valori della Resistenza?
La memoria è come un film in bianco e nero.
A volte viene nascosta, chiusa chiave nei cassetti della storia.
Ma altre volte, quella memoria torna, ritorna, e lascia tracce.
Non è memoria buona per anniversari, per tutte le stagioni, buona per parate militari, per finti applausi, buona per politici con la bandiera italiana in mano e l’ipocrisia nel cuore.
E’ memoria viva, quotidiana, un ponte tra generazioni diverse che vivono o hanno vissuti tempi diversi.
E’ un impegno civile, quotidiano, fatto di piccole cose, di gesti, di atti pubblici, soprattutto di parole.
Io racconto una storia a te e tu la racconterai ad altri figli, ad altri amici.
E fino a quando queste storie avranno gambe per poter camminare, queste storie non moriranno mai.
Quando qualcuno si stancherà di raccontarle, queste storie moriranno due volte, con le persone e con le ingiustizie.
“I gendarmi del revisionismo” e “I gendarmi della memoria”.
Si, siamo fieri e orgogliosi di questa definizione, siamo proprio i “gendarmi della memoria”.
Siamo quelli che hanno deciso di stare da una parte, non abbiamo cambiato bandiera solo per vendere qualche libro in più.
Pensiamo cioè che il peggiore dei partigiani stava dalla parte della democrazia, e il migliore dei repubblichini di Salò era alleato dei nazisti responsabili dello sterminio pianificato di milioni di ebrei e di oppositori politici.
Nessuna parificazione tra partigiani e fascisti.
Il sangue dei vinti non può essere mischiato con quelli dei vincitori.
Niente retorica ma giù le mani dai valori scritti nella nostra Costituzione, la più bella in Europa, valori antifascisti.
Costituzione italiana
Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro.
Art.10
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
E’ per questi e altri motivi che i nostri padri hanno combattuto il fascismo, hanno sognato un paese democratico, un paese in cui un narratore può parlare e voi ascoltare, senza che nessuna milizia armata possa mai attenderci fuori per arrestarci.
Non disperdiamo mai questi valori.
E’ la nostra carta d’identità, il nostro dna, l’unico modo per stare insieme davvero.
Non deve aver dormito tutta la notte. Certi giornalisti sono così.
E’ come chiedere ad un pasticcere “Cosa vuol dire fare i pasticcini”?, oppure ad un falegname “Cosa vuol dire fare i tavoli?”
Certi giornalisti non ce la fanno.
Comunque io ci ho pensato, e gli ho risposto attraverso una storia.
Accadeva molti anni fa dalle mie parti, sull’ appennino tosco-emiliano, non lontano da Monte Sole e Marzabotto, di sera. Tutti i sabati andava in scena la saga del gnocco fritto. Avete presente la pasta del pane fritta?
La tavola era imbandita, la nonna era in cucina e preparava il gnocco.
Noi invece eravamo una brigata di rompicoglioni, correvano e gridavano.
Intanto gli uomini giocavano a carte e non facevano un beato cazzo di niente.
Il camino era sempre acceso e si sentiva un forte odore di legna bruciata.
E al nonno dicevamo: “siamo in agosto e siamo sudati come dei maiali, dobbiamo tenere sempre acceso sto’camino?”.
E lui urlava come un pazzo: “No, deve essere acceso perché la legna è come le nostre parole”.
Allora a nostra madre chiedevamo se ci fosse uno bravo, ma veramente molto bravo a curare il nonno.
A un certo punto la nonna e le altre donne portavano enormi vassoi: il gnocco fumava, c’erano porzioni abbondanti di salumi e formaggi, enormi bacili di insalata, il pane appena sfornato.
Il nonno usciva lento dalla cantina, aveva tra le mani due bottiglie di vino rosso.
Poi si sedeva a capo tavola. E noi alzavamo sempre più la voce, indisciplinati, rompicoglioni, come quelle moschine che d’estate non ti danno pace, che ti scivolano in bocca mentre tu sei lì sul divano a dormire:
Del resto per essere dei rompicoglioni con la patente da rompicoglioni bisogna mettercela tutta, soprattutto bisogna avere un nemico.
E il nostro nemico era il nonno, era perfetto.
Appena finito di mangiare il nonno si alzava dalla sedia e si piazzava in un divano vicino al fuoco, gli uomini sparecchiavano, le donne lavavano i piatti. Il nonno accendeva la pipa, poi prendeva un bicchiere e si versava la grappa, guardava noi e, con voce forte, diceva: «Allora…».
Il nonno si metteva davanti al camino e si faceva illuminare dal fuoco come Marlon brando in Apocalypse Now, quando continuava a ripetere la stessa frase: “orrore…orrore”.
E noi dicevamo: “Nonno adesso ci fai paura”..
Iniziava così una storia del passato, quando sul crinale dell’ appennino si combatteva una guerra. Prato liberata dagli americani, Bologna ancora in mano ai nazifascisti, e in mezzo c’erano i partigiani del gruppo Stella Rossa.
E dicevamo: “Nonno, ma è possibile che con tutte le storie che finiscono bene, che ce ne sono tante, sempre quella che finisce con i bambini fucilati?”.
Il nonno andava avanti con il suo racconto.
Descriveva in modo minuzioso le serate a lume di candela passate ad ascoltare clandestinamente i messaggi in codice di Radio Londra, lo scalpiccio di stivali dei soldati nazisti sulla ghiaia delle strade di Marzabotto e di Montesole, fuori dalle case, il vento forte che passava tra i vetri, gli spari, le urla, la morte.
Il nonno raccontava di quando i soldati nazisti della 16esima divisione PanzerGranadier circondarono una vasta area tra i fiumi Reno e Setta. Mentre salivano bruciavano le case, le persone che uscivano venivano trucidate davanti all’uscio. E poi non era finita. Perché le persone impaurite risalivano il monte verso San Martino, verso la chiesa di Casaglia.
Lì il maggiore Walter Reder detto il monco ordinò ad un soldato di entrare nella chiesa e uccidere il parroco Don Ubaldo Marchionni. E poi non era ancora finita. I fedeli uscivano dalla chiesa e si trovavano davanti i mitragliatori. Qualche ragazzino si lanciò nel dirupo o si nascose nei cespugli. Altri vennero accompagnati al cimitero di Casaglia dove, se andate e portate i vostri figli, troverete delle croci di ferro bucate da pallottole a venti centimetri, per colpire i bambini che si nascondevano dietro ai corpi dei loro genitori.
Ma alcune volte il nonno si dimenticava se la sera prima di quel…29 settembre 1944 c’erano le stelle oppure pioveva, tanto che dicevamo: “nonno, facciamo così, fai un’assemblea con te stesso, nomina una maggioranza e un’opposizione, poi ci dici se il 28 settembre 1944 c’erano le stelle oppure pioveva”
Ogni sera la storia che il nonno raccontava era così uguale ma così diversa.
C’era sempre un elemento in più che rendeva il suo racconto affascinante e mai noioso: un taglio di luce particolare, un gioco di ombre, un temporale, il chiarore delle stelle, un odore, soprattutto la passione. Fino a quando quelle storie saranno raccontate alle generazioni future ci sarà memoria. Se il filo si spezza, si perde la conoscenza del passato, non si comprende il presente e non si potrà vivere il futuro.
Ecco perché anche noi questa sera facciamo teatro e musica d’impegno civile.
Per non dimenticare.
24 luglio 1943, ore 17: inizia la riunione del Gran Consiglio del Fascismo, organismo costituzionale e direttorio politico del Partito Nazionale Fascista, Alle 3 di notte del 25 luglio, viene approvato l’ordine del giorno dei gerarchi Giuseppe Bottai, Dino Grandi e Galeazzo Ciano, prevede la restituzione dell’alto comando al Re. Benito Mussolini viene destituito e subito arrestato.
25 luglio, ore 22:45: il popolo italiano apprende dalla radio che il Re ha assunto il comando supremo delle Forze Armate e il piccolo maresciallo Pietro Badoglio il governo militare del paese con pieni poteri. Poco dopo il piccolo Badoglio indica già le sue prime direttive. Non so se avete presente, il piccolo Badoglio che detta le sue condizioni:
«… la guerra continua e l’Italia resta fedele alla parola data… chiunque turbi l’ordine pubblico sarà inesorabilmente colpito».
Benito Mussolini, ormai ridotto a un ducetto, viene trasferito per tre giorni alla caserma della Legione Allievi Carabinieri, nel quartiere Prati di Roma. Poi spostato via mare nelle isole di Ventotene, Ponza, Maddalena. Infine, rinchiuso in una cella a Campo Imperatore, sorvegliato da duecentocinquanta uomini tra carabinieri e guardia di finanza.
Ovunque, nelle città e nei paesi, manifestazioni di piazza salutano la caduta del regime fascista.
8 settembre 1943, ore 19:45: dopo cinque giorni di lunghe ed estenuanti trattative, il piccolo Pietro Badoglio annuncia l’armistizio dai microfoni dell’E.I.A.R.:
«Il governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di continuare l’impari lotta contro la schiacciante potenza avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi danni alla nazione, ha chiesto l’armistizio al generale Eisenhower… La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza».
Roba da duri, gente con le palle, gente che non ha paura, che sfida il nemico a testa alta, direte voi. E invece…..
9 settembre, ore 5,10
Come fanno i topi, presto, di mattina, il Re, la famiglia reale e Pietro Badoglio, seguiti da un corteo di miracolati, composto da generali e funzionari, abbandonano Roma, diretti a Pescara, dove li attende una corvetta che li trasporta in Puglia.
L’Italia è ormai occupata da ore dai nazisti.
L’esercito regolare muore schiacciato da una guerra più grande delle sue possibilità militari, lasciato a sé stesso nelle ore dell’agonia, dal Re e dal comando supremo militare.
Gli ufficiali di professione attendono ordini che non arriveranno mai.
I soldati sfondano le porte, escono dalle camerate, abbandonano le caserme, le armi pesanti e leggere, tutti i loro mezzi, barattano per pochi soldi ogni abito borghese, ogni via di scampo, ogni ritorno a casa.
L’Italia si trasforma in un’immensa retrovia dove i soldati fuggono e si nascondono nelle case di famiglia, nei boschi, nelle valli, tra sentieri impervi, piccoli borghi e rifugi di montagna.
Il governo regio fuggiasco a Brindisi crede di poter tornare entro pochi giorni a Roma alla guida del paese, ma le quattordici divisioni della Seconda e Ottava Armata italiana si sciolgono al confine orientale, il corpo motocorazzato schierato a difesa della Capitale si arrende, della Settima Armata si salvano solo le divisioni raggiunte dalle truppe inglesi.
Intanto il feldmaresciallo Erwin Rommel liquida le nostre armate al Nord, il feldmaresciallo Albert Keserling quelle del Sud, mentre si oppone alle forze anglo-americane, sbarcate a Salerno e Taranto.
E allora?
Che si fa quando tutto sembra perduto?
Quando non si vede nemmeno l’ultimo spiraglio di luce?
Quando intorno c’è il buio del terrore e dell’occupazione?
E allora che si fa ?
E allora inizia la Resistenza.
La guerra dell’Italia partigiana incomincia proprio quando termina la guerra del regime.
L’armata ribelle si forma dopo la disfatta di quella regia e fascista.
Certo, all’inizio sono poche migliaia di persone.
Di notte, qualcuno a Cuneo nota ombre che scivolano lungo i muri delle caserme, fino alle finestre delle armerie.
Sono Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Benedetto Dalmastro che prendono le armi.
Saranno l’avanguardia del movimento di Giustizia e Libertà nel cuneese.
In certi luoghi di montagna mentre scendono a valle i soldati dell’esercito in rotta, risalgono gruppetti di studenti universitari, operai delle fabbriche delle città, ufficiali del corpo degli alpini, intellettuali, scrittori, giornalisti, professionisti affermati, contadini,
“Dove andate? – Andiamo in montagna a riprenderci le vostre posizioni. Venite con noi?”
La minoranza del settembre 1943 è l’avanguardia di una Resistenza che ha radici lontane: nelle fabbriche, nei campi, nelle scuole, nelle prigioni, tra i fuoriusciti in Francia e i confinati a Ventotene, fin dentro l’esercito fascista.
13 settembre 1943: la radio tedesca annuncia la liberazione di Benito Mussolini dalla sua prigione, un albergo sul Gran Sasso d’Italia. Il giorno dopo il Duce va a Rastenburg, in Germania, in aereo. Hitler lo attende davanti al bunker. Mussolini è nelle sue mani, il Führer è il suo padrone politico e militare. Il Duce è ormai un fantoccio del Terzo Reich.
18 settembre 1943: da Radio Monaco, Benito Mussolini riprende le redini del “nuovo fascismo” nato sotto l’ombrello nazista:
«Riprendere le armi a fianco della Germania e del Giappone, nostri alleati… preparare senza indugio le nostre Forze Armate attorno alle formazioni della Milizia… eliminare i traditori…».
Nell’Italia occupata dai nazisti nasce la Repubblica Sociale Italiana.
Da una parte si schierano i soldati della repubblichina, dall’altra prendono forma le bande partigiane.
I ribelli si posizionano dove possono, dove ci sono montagne, colline, boschi, e nelle scuole e fabbriche delle città, praticamente dappertutto.
I loro numero cresce gradualmente nei mesi della lotta di Liberazione: 2mila (settembre 1943), 4mila (novembre 1943), 25mila (aprile 1944), 80mila (marzo 1945), 130mila (inizio aprile 1945), 250mila (fine aprile 1945).
Per i ribelli saranno anni lunghi, difficili, febbrili.
Prendere armi, sotterrare armi dappertutto: nei boschi, nelle baite, di montagna, negli scantinati dei palazzi delle città, perfino nelle tombe dei piccoli cimiteri.
Trasportare armi con carri riempiti di segatura, coperti di fascine, di fieno.
Prendere farina, lardo, pane, benzina.
Scambiare sale con olio e olio con munizioni.
Cercare vestiti, scarpe, calzettoni di lana, tagliare legna, cuocere cibo per centinaia di persone, fabbricare letti con tronchi di pino e sacchi di paglia e di foglie, curarsi dalla scabbia, dai pidocchi.
Sparare precisi senza consumare colpi inutili, tenere le armi in sicurezza, abbandonare e conquistare postazioni, fuggire da attacchi improvvisi del nemico, sganciarsi dai rastrellamenti, lanciarsi in dirupi scoscesi, in riddani bui e spaventosi, con zaini pesanti, sotto piogge torrenziali, nevicate, sotto il caldo sole di agosto.
Fare i turni di notte in mezzo alla nebbia fitta, ascoltare i rumori dei boschi, dove anche il più impercettibile fruscio può rappresentare un pericolo, girare radenti ai muri delle case, mischiarsi alla folla delle piazze delle città.
Stampare giornali clandestini, distribuirli attraverso camioncini coperti da cassette di frutta e verdura, sporte delle donne, carrozzelle dei bambini, tricicli da negozio.
E ancora comprendere il linguaggio della povera gente, capire i loro bisogni, i dialetti, la psicologia della montagna, gli sguardi solitari dei montanari.
E decifrare i segreti di città grigie, morte quando scende la sera ed entra in vigore il coprifuoco, dove per le strade si incontrano solo le pattuglie tedesche e fasciste e le loro camionette.
E infine vivere nel silenzio di case senza acqua, luce, riscaldamento, in città dove le razioni delle tessere annonarie sono appena al livello della mera sussistenza, dove ci si muove di notte come gatti tra migliaia di case distrutte dai bombardamenti e di giorno nella paura di essere arrestati, incarcerati, torturati, fucilati senza alcun avvocato che ti difende e senza alcun processo.
Nel 1944 l’Italia del Nord era tutta occupata dai nazisti e dai repubblichini.
In autunno, si concentrano nelle Langhe qualcosa come 15mila partigiani.
Arrivano da tutte le parti, un vero e proprio esercito.
Ci sono le Brigate Garibaldi con i fazzoletti rossi, ci sono le formazioni autonome di Mauri, del Capitano North.
I partigiani mandano i preti a trattare con i fascisti.
“Quelli sono quindicimila, voi neanche 5 mila, se scendono dalle montagne vi fanno un mazzo così”.
I fascisti sgomberano Alba e sanno che torneranno.
I partigiani scendono dalle colline e occupano Alba e sanno che dureranno poco.
Ma devono farlo.
Devono dimostrare che possono governare anche una grande città. E non importa se la perderanno perché il futuro sarà quello dei partigiani, non quello dei fascisti e nazisti.
Così Beppe Fenoglio descrisse “I ventitré giorni della città di Alba”
……Stavolta c’erano, proprio di fronte, e si tirarono su dalla molle terra e spararono con tutte le armi, avendo i mirini accecati dal fango. Ora finalmente si vedevano, verdi e lustri come ramarri, ognuno col suo bravo elmetto, e il primo doveva essere un ufficiale, stava tutto diritto e si passava una mano sul viso per toglierne la pioggia. Un attimo dopo, era ancora diritto, ma le sue due mani non gli bastavano più per tamponarsi il sangue che gli usciva da parecchi punti della divisa.
C’erano di qua mitragliatrici americane e di là tedesche, e insieme fecero il più grande e lungo rumore che la città di Alba avesse sino allora sentito. Per circa quattro ore, per il tempo cioè che i partigiani tennero San Casciano, fischiò nei due sensi un vento di pallottole – che scarnificò tutti gli alberi, stracciò tutte le siepi, spianò ogni canneto, e fece naturalmente dei morti, ma non tanti, una cifra che non rende neanche lontanamente l’idea della battaglia.
Così, dalle sette fino alle undici passate, quei dilettanti della trincea inchiodarono i primi fucilieri della repubblica, uomini che sbalzavano avanti e poi s’accucciavano e viceversa a trilli di fischietto, assaltatori ammaestrati.
Un po’ dopo le undici, in un riposo che sembrava si fossero preso i fascisti, quelli giù a San Casciano videro affacciarsi tra gli alberi di Castelgherlone un partigiano, e verso di loro faceva con le braccia segnali disperati. Come vide che da basso non lo capivano, si scaraventò giù per il pendio mentre, forse per fermare proprio lui, i fascisti riprendevano a sparare. Quel partigiano arrivò scivoloni nel fango e disse che la repubblica, visto che al piano non passava, s’era trasportata in collina, in faccia a Castelgherlone, preso il quale, avrebbe aggirato dall’alto San Casciano. Portarsi tutti in collina e spicciarsi, adunata a Cascina Miroglio, perché Castelgherlone l’abbandonavano a momenti. Lui tornò su, i partigiani saltarono fuori dalla trincea, sgambavano già nel fango verso la collina senza aspettarsi l’un l’altro, a certuni scivolavano dalle spalle le cassette delle munizioni e non si fermavano a raccoglierle, quelli che seguivano facevano finta di non vederle.
Il pendio di Cascina Miroglio è ben erto, i piedi sulla terra scivolavano come sulla cera, unico appiglio l’erba fradicia. Qualcuno dei primi scivolò, perse in un attimo dieci metri che gli erano costati dieci minuti, finiva contro le gambe dei seguenti oppure questi per scansarlo si squilibravano, cosi ricadevano a grappoli improperandosi. Qualcuno, provatosi tre o quattro volte a salire e sempre riscivolato, scappò per il piano verso la città e fu perso per la difesa.
Arrivarono sull’aia della cascina vestiti e calzati di fango. A Cascina Miroglio c’era il Comandante la Piazza, un telefono da campo che funzionava e i mezzadri inebetiti dalla paura che porgevano macchinalmente secchi d’acqua da bere.
Marciando piegati in due arrivarono per la vigna gli uomini della mitragliera di Castelgherlone. Ma la grande arma non veniva con loro, l’avevano lasciata perché le si era rotto un pezzo essenziale. Gli altri, a quella vista, si sentirono stringere il cuore come se, girando gli occhi attorno, si fossero visti in cento in meno.
Era mezzogiorno, chi s’affacciò colle armi alle finestre, chi si postò dietro gli alberi, altri fra i filari spogli della vigna. E spararono alla repubblica quando sbucò dal verde di Castelgherlone. Piombò una mortaiata giusto sul tetto e il comignolo si polverizzò sull’aia. Un partigiano venne via dalla finestra per andare a raccogliere sul pavimento la mezzadra che c’era cascata svenuta.
Difesero Cascina Miroglio e, dietro di essa, la città di Alba per altre due ore, sotto quel fuoco e quella pioggia. Ogni quarto d’ora l’aiutante si staccava dal telefono e si sporgeva a gridare: – Tenete duro che vi arrivano i rinforzi! – Ma fino alla fine arrivarono solo per telefono.
In quel medesimo giorno, a Dogliani ch’è un grosso paese a venti chilometri da Alba, c’era la fiera autunnale e in piazza ci sarà stato un migliaio di partigiani che sparavano nei tirasegni, taroccavano le ragazze, bevevano le bibite e riuscivano con molta facilità a non sentire il fragore della battaglia di Alba.
Che così fu perduta alle ore due pomeridiane del giorno 2 novembre 1944.
Fu il Comandante la Piazza a dare il segno della ritirata, sparò un razzo rosso che descrisse un’allegra curva in quel cielo di ghisa. Parve che anche i fascisti fossero al corrente di quel segnale, perché smisero di colpo il fuoco concentrato e lasciavano partire solo più schioppettate sperse.
Tutti avevano già spallato armi e cassette, ma non si decidevano, vagabondavano per l’aia, al bello scoperto. Pensavano che Alba era perduta, ma che faceva una gran differenza perderla alle tre o alle quattro o anche più tardi invece che alle due. Sicché il Comandante fu costretto a urlare: – Ritirarsi, ritirarsi o ci circondano tutti! – e arrivava di corsa alle spalle dei più lenti, come fanno le maestre coi bambini delle elementari.
Scesero la collina, molti piangendo e molti bestemmiando, scuotendo la testa guardavano la città che laggiù tremava come una creatura.
Qualcuno senza fermarsi raccattò una manata di fango e se la spalmò furtivamente sulla faccia, come se non fossero già abbastanza i segni che era stata dura. È che la via della ritirata passava per dove la città dà nella campagna: li c’erano ancora molte case e si sperava che ci fosse gente, donne e ragazze, a vederli, a vederli cosi. Ma quando vi sbucarono, nel viale del Santuario quant’era lungo non c’era anima viva, e questo fu uno dei colpi più duri di quella terribile giornata. Soltanto, da una portina uscì una signora di più di cinquant’anni, al vederli scoppiò a piangere e diceva bravo a tutti man mano che la sorpassavano, finché da dietro un’imposta il marito la richiamò con una voce furiosa.
Tagliarono il viale del Santuario e andando contro l’acqua che ruscellava giù per la stradina, attaccarono a salire la collina di Belmondo che è il primo gradino alle Langhe. A mezza costa si fermarono e voltarono a guardar giù la città di Alba. Il campanile della cattedrale segnava le due e dieci. Gli arrivò fin lassù un rumore arrogante, guardando a un tratto scoperto di via Piave videro passarci due carri armati, e poi altri due, ciascuno con fuori dell’orlo una testa con casco. Oh guarda, così avevano i carri e non li hanno nemmeno adoperati.
I partigiani ripresero a salire, era spiovuto, i fascisti entrarono e andarono personalmente a suonarsi le campane.
Così andò a finire la battaglia di Alba.
Il 2 novembre 1944.
Dal 1943 al 1945, l’Italia occupata dai nazisti diventa un enorme mattatoio dove gli oppositori al regime fascista vengono arrestati illegalmente dalle polizie ufficiali, da quelle segrete, dalle tante compagnie di ventura disseminate nella Repubblica Sociale Italiana.
Partigiani ed ebrei vengono trasferiti in via Tasso a Roma, a Villa Triste a Firenze, in via Bolognese 67, a Villa Fossati a Milano in via Paolo Uccello 15, a Trieste in un edificio di via Bellosguardo, a Genova alla Casa dello Studente, a Biella a Villa Schneider.
E ancora trascinati negli scantinati di palazzi, retrobottega di negozi, rinchiusi in pensioni anonime come Oltremare in via Principe Amadeo 2 e Jaccarino in via Romagna a Roma, trasformati in luoghi di detenzione come il palazzo Carmagnola di via Rovello a Milano, dove la tortura è una pratica sistematica per i prigionieri.
Contro gli antifascisti si specializzano i peggiori aguzzini.
Sono i sanguinari delle strutture degli apparati dello Stato della RSI, gli assassini delle compagnie di ventura, i contabili della morte del fascismo.
C’è l’Esercito Nazionale Repubblicano con la Guardia nazionale Repubblicana di Renato Ricci e le Brigate nere di Alessandro Pavolini, segretario del Partito Fascista Repubblicano.
Ci sono i militari della Legione SS Italiana, unità affiliata alle Waffen SS alle dipendenze di Karl Wolf.
Ci sono i battaglioni operativi della Xmas di Junio Valerio Borghese.
C’è il raggruppamento paracadutisti Nembo.
A Roma in via Tasso, i fascisti collaborano con Herbert Kappler e la sua Sicherheitdienst polizei, SIPO.
A Firenze è operativa la 92esima legione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, la banda di Mario Carità.
A Trieste lavora l’ Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza per la Venezia Giulia.
A Cuneo e a Milano è attiva la Legione Autonoma Mobile Ettore Muti di Franco Colombo.
E sempre nella capitale della Resistenza arriva da Roma Pietro Koch, l’allievo che supera il maestro Mario Carità.
Pietro Koch ha il crimine nel sangue.
Fonda una sua banda, Così la banda Koch.
Vi aderiscono i preti Pasquino Perfetti e Ildefonso Troya, l’avvocato Augusto Trinca Armati, il giornalista Vito Videtta, gli attori Luisa Ferida e Osvaldo Valenti, l’esperto dei servizi segreti Francesco Argentino, il vice comandate operativo Armando Tela, il conte Guido Stampa, Alba Cimini, Marcella Stopponi, la soubrette Daisy Marchi, Lina Zini, Camilla Giorgiatti, gli agenti Cabruccio Cabrucci, Nestore Santini, Francesco Belluomini, Vito Videtta, l’ex gappista Guglielmo Blasi e altri.
La banda Koch è una confluenza di psicopatici, mitomani, sadici, degenerati, criminali comuni, cocainomani, esaltati, prostitute, delatori, spie.
La carovana della morte, il Reparto Speciale di Polizia guidato da Pietro Koch scivola lungo l’Italia come serpe affamata, cerca uomini e donne con idee diverse per placare la sua sete di sangue.
Il Reparto Speciale di Polizia entra nelle loro case.
Li stana come animali braccati: incatena le loro mani.
Mani grosse.
Non affusolate e ben curate come quelle degli aguzzini, ma mani da macellai, enormi.
Mani di contadini rugose, screpolate.
Mani di meccanici, sempre un po’ macchiate d’olio esausto.
Mani di donne giovani, ma già abituate a tirar su tre figli: mani forti per non crescere delinquenti, mani delicate per non lasciarli in balia della notte, svegli.
Mani di lavoratori che non hanno orario se non seguire la luce del giorno e l’oscurità della notte.
Mani callose di falegnami.
E poi ancora.
Mani di elettricisti coi capelli lunghi tenuti legati dietro la testa.
Mani di operai e manovali capaci di alzare 150 chili senza la paura di cadere sfiniti.
Mani di carta vetrata, con la polvere che è ormai tutt’uno con la pelle, sono le mani dei minatori di pietre che feriscono talvolta.
E tuttavia non fanno male come le bastonate che schioccano quei vigliacchi in guanti neri o guanti bianchi.
Aguzzini le cui mani sotto la pregiata stoffa che le nasconde sono rosse di sangue altrui, incancrenite di dolore appiccicato per sempre, eterna condanna.
Una volta che ha completato il carico, la carovana della morte, il Reparto Speciale di Polizia riprende il suo viaggio per giungere alla destinazione finale.
Quando gli aguzzini di Pietro Koch entrano nelle case di antifascisti ed ebrei tutti rubano i loro averi.
Poi trasferiscono i detenuti nelle camere di sicurezza.
Le persone arrestate vengono fatte oggetto di sevizie particolarmente efferate: formidabili pugni, schiaffi, calci, colpi inferti mediante bastoni di legno e di ferro, anche a spirale intrecciata e retrattili, frustini, nervi di bue, fustigazione dei testicoli.
I detenuti vengono portati in una cella detta carbonaia, richiusi in un pertugio detto buco, legati in due l’uno all’altro e appesi per giorni senza mangiare.
Alcuni sono costretti a pulire il pavimento dal proprio sangue con i gomiti.
Altri vengono trasportati per le scale tenendoli per i piedi così che il capo batte ogni scalino.
Colpi fortissimi vengono inferti alla regione cardiaca e al centro dello stomaco, oppure dritti contro gli occhi e le orecchie per provocare cecità e sordità, oppure ancora colpi alla mascella diretti a svellere i denti.
Ad altri ancora viene applicato alla fronte un semicerchio di ferro con due punte alle tempie oppure un telaio in legno che comprime il corpo umano contro una striscia chiodata.
Per i detenuti si alternano docce gelide e bollenti, gelide e bollenti, gelide e bollenti, così per ore, che diventano ore.
Tortura per estorcere informazioni preziose, per demolire la dignità delle persone, per ucciderle…
Ma non subito… no…
Poco alla volta…
Gli aguzzini ne studiano di notte e di giorno… bisogna esserci portati… non si possono compiere certi atti efferati e magari poi tornare a casa, baciare i propri figli come se nulla fosse successo…
Non puoi dire che torturi solo per il piacere di veder soffrire vite umane…
Torturi perché vuoi annullare ogni possibilità di opporsi ad un sistema che tu stesso hai costruito.
Non é una follia patologica, è una lucida consapevolezza.
Case anonime, garage, ville che si trasformano in centri di detenzione.
Luoghi di tortura dove si entra e non si esce vivi.
Gli stessi che anni dopo sono apparsi in Cile durante la dittatura di Augusto Pinochet (Villa Grimaldi), in Argentina durante la repressione contro gli oppositori ordinata dai generali Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Leopoldo Galtieri, Roberto Eduardo Viola (Garage Olimpo, Esquela de Mecànica de l’Armada), e i ogni luogo del mondo dove i diritti dell’uomo vengono calpestati da soldati e polizie segrete.
Ora se credi ti possa esser bastato
Voglio che mi accompagni fino in fondo alla caina
Là dove l’uomo non è mai arrivato
Là dove vi è la disumana violenza e la rovina.
Qui l’arte non riesce più a sostenere
La metafora, l’immagine, il suono dell’abisso
Perché il confine non lo puoi oltrepassare
Perché laggiù l’uomo, non è più uomo: è crocifisso.
Le menti lucide di carnefici senza ritegno
Annullano il concetto primitivo di razza umana
Non riesco più a pensare, abbasso gli occhi e mi sdegno
Di fronte ad un boia ancor più feroce di una mammana.
Cosa può esserci di più tremendo di violenta morte?
Cosa si può immaginare che superi qualsiasi aberrazione?
Apri gli orecchi quel che sto per dirti è veramente troppo forte
E se vuoi andartene, fallo ora, è la tua ultima occasione.
Per dirti quello che ti ho detto non ho usato mezze parole
Perché se dici di appartenere al genere umano
È ora di illuminare la coscienza con il sole
È ora di gridare, agire e fare un gran baccano.
Chino il capo come uomo abbattuto da altro uomo
Non chiedo perdono per i boia degli abissi
Taccio, ma non sarò mai domo
E griderò con tutta la mia rabbia e con gli occhi vergognosi e bassi
Che ormai il tempo della giustizia è tramontato
Questo è il tempo della verità e dei grandi passi.
Come ricordare oggi i valori della Resistenza?
La memoria è come un film in bianco e nero.
A volte viene nascosta, chiusa chiave nei cassetti della storia.
Ma altre volte, quella memoria torna, ritorna, e lascia tracce.
Non è memoria buona per anniversari, per tutte le stagioni, buona per parate militari, per finti applausi, buona per politici con la bandiera italiana in mano e l’ipocrisia nel cuore.
E’ memoria viva, quotidiana, un ponte tra generazioni diverse che vivono o hanno vissuti tempi diversi.
E’ un impegno civile, quotidiano, fatto di piccole cose, di gesti, di atti pubblici, soprattutto di parole.
Io racconto una storia a te e tu la racconterai ad altri figli, ad altri amici.
E fino a quando queste storie avranno gambe per poter camminare, queste storie non moriranno mai.
Quando qualcuno si stancherà di raccontarle, queste storie moriranno due volte, con le persone e con le ingiustizie.
“I gendarmi del revisionismo” e “I gendarmi della memoria”.
Si, siamo fieri e orgogliosi di questa definizione, siamo proprio i “gendarmi della memoria”.
Siamo quelli che hanno deciso di stare da una parte, non abbiamo cambiato bandiera solo per vendere qualche libro in più.
Pensiamo cioè che il peggiore dei partigiani stava dalla parte della democrazia, e il migliore dei repubblichini di Salò era alleato dei nazisti responsabili dello sterminio pianificato di milioni di ebrei e di oppositori politici.
Nessuna parificazione tra partigiani e fascisti.
Il sangue dei vinti non può essere mischiato con quelli dei vincitori.
Niente retorica ma giù le mani dai valori scritti nella nostra Costituzione, la più bella in Europa, valori antifascisti.
Costituzione italiana
Art. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro.
Art.10
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Art. 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
E’ per questi e altri motivi che i nostri padri hanno combattuto il fascismo, hanno sognato un paese democratico, un paese in cui un narratore può parlare e voi ascoltare, senza che nessuna milizia armata possa mai attenderci fuori per arrestarci.
Non disperdiamo mai questi valori.
E’ la nostra carta d’identità, il nostro dna, l’unico modo per stare insieme davvero.
envoyé par DoNQuijote82 - 24/12/2012 - 15:42
×
![]()
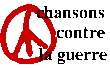








Storie dell'altra Italia
Portata in scena e musicata da Daniele Biacchessi, Gang e Massimo Priviero in "Storie dell'altra Italia"